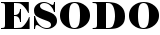Continuiamo la nostra riflessione "a monte" delle contingenze su alcune domande di fondo sul tema della pace con l'intervento di Piero Stefani
1. Il cristiano di fronte al male nella storia o meglio dentro il male. Riprendendo Bonhoeffer, che considera l’incarnazione come legge della storia, il cristiano sa che qualsiasi azione compia rimane nel peccato. Nella storia non si pone l’alternativa astratta tra il Bene assoluto e il Male assoluto. Qualsiasi azione facciamo per compiere il bene si rimane nella situazione di peccato: comporta assumere il rischio della scelta personale nella situazione concreta con la fede nella misericordia di Cristo che ha preso su di sé il peccato e lo ha vinto.
Compiere un’azione che si ritiene necessaria per raggiungere un bene, come uccidere il tiranno o partecipare alla guerra per la libertà del proprio popolo, è quindi contemporaneamente bene e male, giusto e peccato. Se è così, è una contraddizione interna alla coscienza personale del cristiano ma ha anche significati per la Chiesa e per l’etica umana collettiva?
Vi è un detto che riprendo senza compiere alcuna indagine filologica: «il fine giustifica i mezzi». Il conseguimento di uno scopo buono consente il ricorso a strumenti in sé stessi negativi i quali, a causa di questa loro funzione, diventano, di fatto, a loro volta positivi. È facile applicare questa logica alla rivoluzione (lo fece con nettezza e coerenza Robespierre). La replica sul piano etico-storico a questa opzione è evidente: il fine da conseguire è incerto e, in ogni caso, è lungi dal presentarsi come un bene assoluto, perciò la negatività dei mezzi non è riscattata, a priori, dalla bontà dello scopo. Ciò non vale solo per la rivoluzione. Anche la vecchia teoria della guerra giusta è, in realtà, legata al principio che il fine giustifica i mezzi. L’atto di mostrare l’inadeguatezza di quest’ultima visione non comporta, però, che ogni guerra sia da evitare; la conclusione da trarre è piuttosto che nessuna guerra può dirsi innocente. Per rendersene conto occorre scavare in concetti anche teologici, a iniziare da quelli di sacrificio e di punizione.
Sacrificio. Il discorso sui mezzi si presenta soprattutto quando si afferma il valore assoluto della meta da perseguire. È il caso della dimensione sacrale del sacrificio in cui l’uccisione della vittima diviene uno strumento di espiazione. Ciò vale anche in ambito cristiano in riferimento alla concezione teologico-sacrificale della croce. La morte di Gesù Cristo da un lato espia ogni peccato mentre, dall’altro, colpevolizza gli uccisori. Il fatto che si tratti di una visione teologica non più universalmente accolta, non elimina il dato di fede che Gesù ha offerto la propria vita per il riscatto di tutti. Sacrificare la propria vita a favore di altri è, anche sul piano umano, l’atto più nobile, tuttavia, esattamente come avviene per il martirio, esso implica sempre la colpa da parte di chi uccide (o di chi sfrutta).
Le considerazioni fin qui compiute sono volte a indicare un ragionamento a minori ad maius: se anche l’atto di sacrificare la propria vita implica il peccato di chi la sopprime, a maggior ragione l’atto di salvaguardare la propria vita, in senso individuale o collettivo, comporta un peccato, in questo caso connesso in più occasioni, anche ai mezzi a cui si fa ricorso, per difendere sé stessi o altri.
L’ambiguità insita in ogni sacrificio diventa stravolta quando viene declinata in un aberrante linguaggio ideologico. Lo ha esemplificato Putin allorché il 18 marzo scorso ha applicato all’invasione dell’Ucraina il detto giovanneo secondo il quale non c’è amore più grande di quello di dare la vita per i propri amici (Gv 15,13). Tuttavia non è sufficiente smascherare, come pur si è tenuti a fare, simili derive per uscire dall’ambiguità di rispondere al male – che in ogni caso è già inscritto nel mondo – con atti mai del tutto innocenti. C’è una differenza irriducibile tra resistere al male essendo uccisi oppure uccidendo; l’essere uccisi in modo sacrificale o martiriale deve, però, presentarsi sempre e solo come una scelta compiuta in prima persona, senza coinvolgere altri o senza esservi costretti («coscrizione obbligatoria»). Inoltre va compiuta soltanto se si reputa che essa abbia uno scopo o trascendente o immanente, in questo caso esso si esplica a favore di coloro che continuano a vivere anche a causa del sacrificio compiuto. Quest’ultimo ambito non è però mai esente dalle incertezze che contraddistinguono il futuro. La storia registra molti sacrifici umanamente inutili. In tono più lieve, si pensi alle ben note lamentele genitoriali di un tempo: ho compiuto tanti sacrifici per te…
Punizione. La forma più comune di rispondere al male con il male è la punizione, la quale, intesa come mezzo, diviene un bene. Non c’è bisogno di rivolgersi né alla vita familiare, né al sistema carcerario per comprendere quanto la presenza di un’utilità collocata nel futuro renda incerto l’esito. La punizione è nel presente, il suo eventuale frutto è in un indefinito domani. Ciò non significa che non bisogna mai punire, pure in questo caso occorre però evitare di esaltare i mezzi. Anche quando questi ultimi sono individuati con cura, l’atto di punire non può mai dirsi completamente innocente. Non va dimenticato che uno dei meccanismi sacrifical-espiatori sta nel fatto che una vittima innocente sia punita in luogo dei colpevoli.
Nell’ambito della violenza bellica, l’ambiguità della dinamica punitrice-vendicativa è stata smascherata dal linguaggio violento del profeta Amos. Un esempio particolarmente significativo è contenuto nell’oracolo rivolto contro Edom, (i discendenti di Esaù cfr. Gen 25,19-30). La sua colpa è di aver inseguito con la spada il proprio fratello, di aver soffocato la misericordia nei suoi confronti e di non aver posto tregua all’ira; per questo Dio darà fuoco alla sua capitale (Am 1,11). La violenza non è innocente neppure quando punisce il colpevole. Edom è colpevole, ma non lo è meno Moab che ha bruciato e calcinato le ossa del re di quella prima popolazione (Am 2,1). Nessun agente storico può arrogarsi il ruolo di punire invece di Dio. Edom è colpevole, ma Moab lo è a sua volta quando lo colpisce. Il fatto che Amos proponga immagini violente di Dio che incendia capitali e devasta palazzi non deve trarre in inganno: esse stanno a indicare che nessuno, a parte il Signore, può attuare quella punizione: quelle figure di devastazione divina proibiscono alle creature umane di devastare.
2. Nell’ambito della teologica morale c’è un termine, non di rado, circondato da ironia: casistica. Atteggiamento simile è assunto nei confronti di determinate discussioni talmudiche, di ordine pratico, accusate di spaccare il capello in quattro. Le valutazioni negative possono avere senso nel momento in cui prendono le distanze dal convincimento di riuscire a decidere in ogni circostanza, reale o ipotetica, quale atto sia conforme alla morale o sia in grado di applicare correttamente il precetto. I rilievi critici sono invece fuori misura se non comprendono che questi sforzi, per quanto inadeguati, si misurano con il perenne problema di calare un «dover essere» formulato in termini generali in un «essere» che si presenta sotto una incontenibile molteplicità di aspetti; per esprimere la stessa idea in altro modo: siamo di fronte a un tentativo di adeguare la vita alla norma obbligato, a propria volta, a confrontarsi con il processo inverso di conformare la norma alla vita. Affermare che si è costretti dalle circostanze ad agire in un determinato modo è un’evidente maniera di scansare le proprie responsabilità etiche. I criteri di discernimento si pongono, però, sullo stretto crinale che separa il «dover essere» dall’«essere». Ciò significa che l’agire morale implica un difficile e intelligente sforzo diretto a comprendere gli accadimenti. La legge di Hume in base alla quale nessuna descrizione fonda una prescrizione è corretta; tuttavia, è giusto anche affermare che l’applicazione di ogni prescrizione non può prescindere dalla descrizione. Riguardo alla situazione presente, ciò comporta conoscenze storiche e geopolitiche in gran parte ignote a coloro che intervengono nel dibattito pubblico sull’invasione russa dell’Ucraina (ciò vale, ovviamente, anche per altre situazioni e, con le varianti del caso – conoscenze medico-scientifiche - anche per le questioni bioetiche).
La cultura letteraria italiana contiene un grande esempio (per quanto situato in un troppo lungo post-eventum) di questo pensoso modo di procedere, è La storia della colonna infame. Lo scopo dell’operazione manzoniana, oltre a essere storico ed etico, diviene, in un certo senso, anche teologico. Infatti, in un passo di questo suo saggio, Manzoni afferma che se i giudici, vittime dei tempi barbari in cui vivevano, non avessero davvero potuto far altro che emettere quel tipo di sentenza (contro i presunti untori), ciò significherebbe che l’uomo è, almeno in determinate circostanze, forzato a fare il male e, se così fosse, ne andrebbe della divina Provvidenza: «Se, in un complesso di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo, crediamo di vedere un effetto de’ tempi e delle circostanze, proviamo insieme con l’orrore e con la compassione medesima, uno scoraggiamento, una specie di disperazione. Ci par la natura umana sospinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata a un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l’indegnazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di que’ fatti, e che pure nello stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l’orrore e scompare la colpa; e cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie, che son due deliri: negare la Provvidenza, o accusarla».
In altre parole, se i carnefici si presentano in un certo senso a propria volta come vittime, in quanto costretti ad agire in modo iniquo dalle circostanze in cui si trovano, la responsabilità umana non ha più fondamento. Tuttavia – prosegue Manzoni – se «guardando più attentamente», grazie a uno studio di straordinaria acribia, si scopre di essere di fronte a un’ingiustizia che poteva essere veduta da quelli stessi che la commisero, allora è dato concludere di trovarsi di fronte a una colpa e non a una scusa, «infatti della violenza si può essere forzatamente vittime, ma quando se ne è autori non la si può compiere che consapevolmente».
Bisogna prendere le distanze sia dallo sdegno a buon mercato di chi vede solo le colpe altrui (restando troppo spesso cieco nei confronti delle proprie), sia dalla rassegnata disperazione di chi scorge nella storia umana soltanto un infinito e inevitabile riproporsi delle atrocità compiute reciprocamente dagli esseri umani.
In questo contesto, l’esistenza della Provvidenza non significa sostenere che tutto vada per il meglio o che Dio, in ogni caso, aggiusti le cose (cioè, come si è soliti dire, scriva dritto sulle righe storte); la visione manzoniana equivale semplicemente ad affermare che all’uomo non è mai negata la facoltà di individuare e di compiere il bene. In questa luce la Provvidenza manzoniana – tanto spesso fraintesa – coincide esattamente con l’esistenza di un «principio di responsabilità», la cui presenza comporta che le creature umane non possano imputare troppo facilmente ad altri (comprese le circostanze e i tempi in cui vivono) il male da loro commesso. Riflettendo sui comportamenti dispiegatisi nel corso della Shoah è stato scritto: «Non è affatto scontato o inevitabile porre l’autoconservazione al di sopra del dovere morale […] Non importa quante persone abbiano preferito il dovere morale alla razionalità dell’autoconservazione, ciò che importa è che qualcuno l’abbia fatto. Il male non è onnipotente. È possibile resistergli» (Z. Baumann, Modernità e Olocausto, il Mulino, Bologna 1992, p. 280). Non pare improprio concludere che resistere al male non equivale a vincerlo: la Shoah è avvenuta e solo un numero limitato di persone ha preferito il dovere morale all’autoconservazione. Per ricorrere a un apparente gioco di parole, la frase significa unicamente che si è sempre responsabili di sottrarsi alla propria responsabilità. Accanto a ciò, occorre sempre avere in mente il detto di Hannah Arendt secondo il quale il più autentico imperativo etico è: cercare di capire.
3. Se è vero che è illusorio pensare possibile la vittoria in tempi brevi degli istinti collettivi alla violenza e alla crudeltà dell’umanità, la rassegnazione è l’unica soluzione? Non c’è una grave responsabilità in particolare delle comunità cristiane e del Magistero della Chiesa per aver agito in senso contrario trascurando totalmente l’educazione a essere operatori di pace?
Il giudizio secondo cui le comunità cristiane e il Magistero abbiano trascurato totalmente l’educazione a essere operatori di pace suona severo e forse ingeneroso. Su questo tema si possono citare una serie assai copiosa di interventi ufficiali di tutti i pontefici dai primi del Novecento fino a oggi (cfr.). Vanno citate anche la «Giornata mondiale della pace», istituita da Paolo VI nel 1968 e la presenza di una miriade di iniziative e prese di posizione più circoscritte (si pensi per es. a Pax Christi). La questione va perciò formulata in altro modo. Il problema più acuto sta nel chiedersi perché tutta questa imponente massa di interventi e documentazioni incida assai poco sul vissuto.
Senza pretendere che sia la ragione maggiore, è dato affermare che uno dei motivi di questa scarsa incisività è la modesta (per non dire nulla) attenzione dedicata alla riflessione sui conflitti interni. Fin dall’origine la storia delle comunità cristiane è contraddistinta dall’eccesso dei contrasti e dalla debolezza delle riconciliazioni. In ciò c’è ben poco che distingua il cristianesimo da altre tradizioni religiose. Nelle Chiese le liti, le divisioni, gli attriti, gli scismi non sono stati meno numerosi che altrove. Non sarebbe difficile redigere un’antologia di passi neotestamentari accomunati dalla presenza di numerosi contrasti e di meno frequenti riconciliazioni. La scelta di mostrare sia la «miseria dei credenti» sia gli esempi nobili rafforzerebbe la consapevolezza di quanto sia grande, anche all’interno della Chiesa, il peso dell’«uomo vecchio». Le comunità delle origini, i concili, il papato medievale, gli ordini religiosi, le diocesi, le parrocchie, i conventi, i monasteri sia di antica fondazione sia eretti nello spirito conciliare, le associazioni laicali si sono rivelati terreni in cui i litigi sono cresciuti prosperosi al pari della zizzania della parabola evangelica. Spesso in questi ambienti, mentre quasi sempre si continua a litigare, si sente evocare il grande dolore che affligge i cuori, la bellezza della riconciliazione, il dono della misericordia, la necessità di una preghiera fervorosa e invocazione dello Spirito. È il lessico interno. In altri contesti ci si appella alla fedeltà agli ideali originari, al servizio da svolgere nei confronti dei cittadini o di altri nobili cause. In realtà, in qualunque ambito ci si trovi, il richiamo alla nostra miseria antropologica è dotato di un grado di verità spesso maggiore di quanto non lo sia l’appello ad alti principi. Può essere che nei nostri occhi non ci sia una trave, tuttavia per invitare credibilmente altri a rappacificarsi occorre prima levare anche la pagliuzza ecclesiale (dato e non concesso che si tratti solo di una pagliuzza).
L’ordine francescano, lo si sa, fu anch’esso fin dal principio pieno di insanabili contrasti; se sopravvive fino a oggi è soltanto in virtù della evangelica santità del suo fondatore. Francesco, nelle ultime settimane di vita, indicò anche una strada per essere operatori di pace. Il Cantico di frate Sole diventò subito così intimo al suo autore da essere chiamato a rappresentarlo. «Laudato sì mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore / et sostengo infirmitate et tribulatione. / Beati quelli ke il sosterrano in pace, / ka da Te, Altissimo, sirano incoronati». Ci troviamo davanti alla cosiddetta «lassa del perdono». Secondo la Leggenda perugina, Francesco venne a sapere del forte e apparentemente incomponibile dissidio che contrapponeva reciprocamente il vescovo e il podestà di Assisi. Nessun ecclesiastico o secolare si dava cura di riconciliarli. Il fatto turbò profondamente Francesco che, malato, non era nelle condizioni di recarsi personalmente sul posto. Inserì perciò i versi sopraddetti nella composizione e inviò dei frati a cantarli di fronte ai due nemici che si trovavano nel chiostro dell’episcopio e predisse che tra loro sarebbe avvenuta una riconciliazione.
Dopo averlo udito cantare, il podestà si mosse per primo al pentimento, subito seguito dal vescovo. La riconciliazione fu suggellata dall’abbraccio e dal bacio, senza che nessuno dei due personaggi rivendicasse a sé stesso una qualche forma di superiorità spirituale o temporale.
Nei versi aggiunti si passa da un «laudato» collegato a un perdono concesso per amore di Dio a un «beati» riservato a coloro che sostengono in pace infermità e tribolazioni. Liberamente, ma non arbitrariamente, si potrebbe affermare che l’animo di Francesco fu tribolato anche a motivo sia dell’odio reciproco tra le due autorità, sia dell’indifferenza di coloro che assistevano inermi a quell’ irrisolto contrasto. Questa duplice tribolazione è segno palese del non rassegnarsi al male. Si vorrebbe perciò concludere che, oltre a reggere in pace le tribolazioni, vi è pure una tribolazione suscitata dalla mancanza di pace. Nel chiostro la recita del Cantico si trasformò in una specie di interposizione nonviolenta che rese vive e presenti le parole di Gesù: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9).
4. La dimensione escatologica con cui il cristiano vive nella storia relativizza quindi i Valori. In questa ottica non si può mai pensare a uno “scontro di civiltà” tra due mondi incarnazione del Bene e del Male, ma si deve fare attenzione critica al male che è presente prima di tutto in se stessi e nella propria “parte” e puntare sul bene esistente nel “nemico”, che non è mai un mondo monolitico, non in modi fideistici e ideologici, ma come indicazione per la capacità di analisi.
Non è questa una posizione realistica che viene proprio dalla dimensione escatologica?
Il problema mi pare più complesso di quanto esposto nella domanda.
Che nella storia non ci sia nulla di assoluto è un’evidenza per tutti coloro che non divinizzano la storia. Qualunque visione sanamente laica giungerebbe alla stessa conclusione. La classica idea illuministica di tolleranza è basata, in gran parte, proprio sulla non assolutezza di bene o male (basti pensare in proposito al celebre aforisma di Voltaire: «Noi siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdonarci reciprocamente le nostre balordaggini è la prima legge di natura»). La peculiarità dell’escatologia non sta solo nel relativizzare il relativo (operazione che si può intraprendere per altre vie); il suo specifico implica la scomparsa del male collocata in una realtà posta dopo la storia: «i cieli nuovi e la terra nuova nei quali abita la giustizia» (2Pt 3,13). In relazione all’escatologia cristiana l’orizzonte si presenta però più articolato: l’esito ultimo è infatti garantito da un avvenimento che, pur trascendendolo, è avvenuto nel tempo: la risurrezione di Gesù Cristo.
Il paradosso cristiano è che il male è già vinto e tuttavia esso continua a operare nel mondo. Questa tensione fa sì che la fine si presenti come Parusia, vale a dire come venuta del Figlio nella gloria. Irrompe in tal modo il tema del tempo intermedio. Esso è presentato da Paolo sotto la prospettiva del «come se non»: «quelli che usano i beni di questo mondo» è «come se non li usassero, passa infatti la figura di questo mondo» (1Cor 7,31). In questa forma di escatologia la relativizzazione raggiunge il proprio apice. Mentre il tempo storico continua a prolungarsi, resta tuttavia arduo, se non impossibile, conformarsi collettivamente a questo stile di vita. Ecco allora che si fanno largo altre prospettive, compresa quella millenarista che attende una radicale svolta nel tempo storico: ci sarà un’età di prosperità terrena in cui «satana sarà legato» (Ap 20). L’avvento del millennio dovrà perciò comportare un previo giudizio sugli empi. In questo caso il rischio di individuare nella storia una contrapposizione tra bene e male assoluti diviene concreta.
Le attese millenaristiche si sono, via via, secolarizzate. Fa parte di questo processo anche l’uso ideologico, ancora attuale, di un linguaggio religioso di stampo messianico-millenaristico. La lotta contro «gli imperi del male», da qualunque parte li si individui, rientra esattamente in quest’ambito. In conclusione, l’escatologia ha quanto meno due facce. La prima relativizza le realtà presenti in nome di un avvenire situato oltre il tempo storico e prospetta, di conseguenza, uno stile di vita “sospeso” («come se non»); l’altra, al contrario, induce gli “eletti” a impegnarsi in una lotta senza quartiere contro il male, o più esattamente contro realtà che sono unilateralmente giudicate malvage. Lo scontro si svolge già nel presente e la vittoria è collocata nel tempo e non già nell’eschaton.
L’appello a una escatologia priva di specificazioni non è sufficiente; il richiamo, infatti, può condurre sia in una direzione sia in quella opposta. Vivere nella prospettiva del «come se non» (ma fino a che punto si è in grado di farlo?) da un lato comporta la presenza di una costante “riserva escatologica”, mentre dall’altro non fornisce indicazioni precise e obbliganti sui modi di «possedere i beni di questo mondo» (espressione da intendersi in senso lato); rispetto a quest’ultimo ambito, perciò, il primato della coscienza e il confronto tra le varie opinioni si presentano come riferimenti imprescindibili. In tal modo si evita il rischio di sentirsi titolari, in maniera personale o collettiva, di una specifica missione storica, convinzione che conduce, molto frequentemente, a conseguenze negative, a volte anche di enorme, tragica portata.