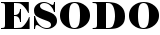Perché l’apertura ai profughi ucraini è una svolta importante
La recente apertura dei confini dell’UE ai profughi ucraini segna una svolta nelle politiche europee dell’asilo. Non sappiamo se rimarrà circoscritta all’attuale emergenza o si allargherà, ma in ogni caso la novità è sostanziale. Per comprenderla, bisogna considerare vent’anni di restrizioni alla mobilità umana indesiderata e di riaffermazione dei confini nazionali.
L’ultimo scorcio del ‘900 aveva prodotto frettolose previsioni del declino degli Stati nazionali e delle loro frontiere, a seguito del crollo dell’impero sovietico e dell’affermazione di una globalizzazione economica e finanziaria apparentemente illimitata. I faticosi progressi nel campo dei diritti umani, insieme al controverso tema dell’ingerenza umanitaria, convergevano nella stessa direzione.
Sebbene le istanze per la limitazione delle migrazioni internazionali fossero già da tempo pressanti, i segnali di risveglio delle preoccupazioni securitarie già visibili, la sovranità nazionale su materie sensibili, come la regolazione degli ingressi o la concessione della cittadinanza, risolutamente difesa dai governi, gli attentati dell’11 settembre 2001 sono assurti a momento emblematico di svolta. Il nuovo secolo si è aperto sotto il segno della riaffermazione della volontà dei governi nazionali, e di riflesso delle istituzioni europee, di ripristinare un più stretto controllo sui confini e sui movimenti migratori, anche a costo di sottrarsi agli obblighi sanciti dalle convenzioni internazionali e di compromettere il proprio impegno per la tutela dei diritti umani.
Di alta priorità per le istituzioni politiche, centrale nel discorso di varie formazioni anti-sistema, sensibile per l’opinione pubblica e per il sistema mediatico, minaccioso per i soggetti impegnati nella difesa dei diritti umani universali, il tema dei confini ha recuperato negli ultimi vent’anni una centralità che pareva consegnata al passato.
- Il rapporto tra confini e sicurezza nazionale
I timori derivanti dall’impatto dei fenomeni migratori sulla sicurezza interna hanno una lunga storia, in cui rientrano il contrasto delle infiltrazioni anarchiche nell’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti a cavallo tra ‘800 e ‘900, o le diffidenze ricorrenti nei confronti dell’attivismo politico delle diaspore attraverso i confini. Già negli anni ’90 del ‘900 l’immigrazione è stata trattata sempre più come un problema di sicurezza dei confini, di cui l’espressione più estrema ed emblematica è fin da allora l’associazione tra immigrazione e terrorismo. Mentre fino agli anni ’70 nell’Europa centro-settentrionale le questioni dell’immigrazione ricadevano sotto le competenze dei ministeri del lavoro e dell’industria, successivamente sono state sempre più assunte dai ministeri degli interni. Anche a livello di istituzioni comunitarie, dagli anni ’90 se ne occupa quella che oggi si chiama DG HOME.
Di certo gli attentati del 2001 e quelli perpetrati negli anni successivi sul suolo europeo hanno influito profondamente nel configurare l’immigrazione come un problema di sicurezza nazionale, collocando in primo piano la questione dell’immigrazione non autorizzata Per citare un solo esempio, il ministro degli esteri spagnolo Josep Piqué dichiarò all’epoca che “la lotta contro l’immigrazione illegale è anche il rafforzamento della lotta contro il terrorismo”.
Negli anni a noi più vicini, l’inquadramento degli arrivi dal mare come un’emergenza, o una crisi di proporzioni mai viste prima, a dispetto dei numeri effettivi, ha contribuito a rafforzare la visione dell’immigrazione come una questione di sicurezza, sia pure dando luogo a varie combinazioni tra una versione più difensiva e una più umanitaria della questione. Un’immigrazione sostanzialmente stazionaria, per quanto riguarda l’Italia, dal 2010 circa, in cui i rifugiati e richiedenti asilo rappresentano non più del 5% dei residenti, con numeri molto più bassi, per esempio, del numero degli alunni stranieri nelle scuole, è stata rappresentata e percepita come una situazione fuori controllo. L’idea vittimistica di un’Italia lasciata sola da un’Europa sorda e indifferente, malgrado un’incidenza dei rifugiati sulla popolazione residente pari a circa 3,5 per 1.000 abitanti, sotto la media dell’Europa occidentale, è un argomento ricorrente e trasversale del discorso pubblico. Il fatto che l’immigrazione nel nostro paese, come nel resto d’Europa, sia prevalentemente femminile, europea, proveniente da paesi di tradizione culturale cristiana, non riesce a entrare nella visione condivisa del fenomeno.
I confini nazionali, e l’impegno dei governi nel difenderli, sono tornati di stringente attualità, tanto da essere definiti “l’ultima importante ridotta di una sovranità nazionale illimitata”. Storicamente, gli Stati moderni non hanno rivendicato soltanto il monopolio della violenza legittima, ma anche quello delle forme legittime di spostamento attraverso i confini, mediante l’introduzione dei passaporti e della relativa infrastruttura burocratica. La loro logica territoriale ha implicato nel tempo un interesse a mantenere il controllo sui propri confini nazionali, sotto tre aspetti: la sovranità interna, di cui la capacità di sorvegliare le frontiere è una delle manifestazioni salienti, mentre l’incapacità di monitorarli è un tratto degli Stati in fallimento; l’autonomia westfaliana, ossia la capacità di regolare i propri affari interni senza interferenze esterne, inducendo i governi a concepire le politiche migratorie come un’area decisionale in cui preservare la propria autonomia; la gestione delle interdipendenze con l’esterno, che giustifica l’importanza attribuita alla gestione ordinata dei flussi transfrontalieri, tra cui quelli delle persone.
- L’esternalizzazione delle frontiere europee
La dimensione esterna degli accordi internazionali non da oggi è un tassello cruciale delle politiche di prevenzione dell’immigrazione indesiderata, compresa quella delle persone in cerca di asilo. L’UE ne è protagonista insieme agli Stati nazionali, anche a costo di sostenere governi dai dubbi standard democratici e di pagare un prezzo in termini di credibilità nella protezione dei diritti umani e nel rispetto delle convenzioni internazionali sull’accoglienza dei rifugiati. La vigilanza dei confini e il contrasto delle possibili infiltrazioni di terroristi hanno fornito una potente giustificazione a queste politiche, nonostante gli scarsi riscontri fattuali di legami tra gli sbarchi e gli attentati sul suolo europeo.
Mediante questi accordi di cooperazione, l’UE tenta di trasformare i paesi ai suoi confini in aree-cuscinetto, concedendo fondi, agevolazioni sui visti, supporto da parte di agenzie come Frontex, addestramento delle guardie di frontiera, fornitura di attrezzature per la sorveglianza, talvolta anche finanziando la costruzione di centri di detenzione.
In termini di architettura dei regimi di mobilità, nell’ambito dell’UE lo sviluppo di un libero mercato del lavoro interno è stato promosso in contrappunto con una chiusura selettiva nei confronti dei lavoratori esterni, di cui il binomio immigrazione non desiderata-sicurezza è un pilastro. L’accordo di Schengen, stabilito nel 1990, dunque subito dopo la dissoluzione dell’impero sovietico, è considerato la pietra angolare di questa politica. In seguito gli accordi di Tampere (1999-2004) hanno fissato tre principali obiettivi: primo, la gestione dei flussi migratori, con riguardo al controllo dei confini e alla lotta contro “l’immigrazione illegale”. Secondo, l’equo trattamento dei cittadini extracomunitari, con riferimento alle procedure di ammissione sul territorio dell’UE e all’integrazione sociale. Terzo, i partenariati con i paesi di origine, relativi alla dimensione esterna delle politiche migratorie. A sua volta, il codice di Schengen del 2006 ha fissato regole comuni per il movimento delle persone attraverso i confini, rafforzando i controlli alle frontiere esterne dell’UE e quasi abolendo in pratica le frontiere interne tra gli Stati aderenti all’accordo.
Mentre l’obiettivo di una politica migratoria comune dell’UE ha raggiunto soltanto alcuni risultati parziali, per esempio nell’elaborazione di norme anti-discriminatorie, l’attenzione dei governi e delle istituzioni comunitarie si è concentrata soprattutto sull’agenda securitaria del controllo dei confini. In quest’area, la cooperazione tra gli Stati membri ha conseguito risultati sostanziosi, simbolizzati soprattutto dalla crescente importanza, l’elevata autonomia e i cospicui fondi attribuiti all’agenzia Frontex.
3. Controlli esterni e interni
In sintesi, gli Stati membri dell’UE non stanno perdendo il controllo sui flussi migratori, come a volte si sostiene, ma si sono rapidamente adattati alle pressioni interne ed esterne ricorrendo a una combinazione di nuove misure finalizzate a porre sotto controllo l’immigrazione indesiderata. Nello stesso tempo, la difesa dei confini è in realtà selettiva: alle chiusure nei confronti di una parte dei candidati all’ingresso si contrappongono le aperture, e persino la generosa accoglienza, nei confronti di altri, privilegiati per nazionalità, censo, competenze professionali. I confini non funzionano come muri in senso assoluto, ma piuttosto come filtri, nell’ambito di regimi di mobilità neo-liberali. I cittadini del Nord del mondo e le élites dei paesi intermedi e in via di sviluppo godono oggi di diritti di mobilità maggiori che in tutto il corso del ‘900, mentre le popolazioni del Sud del mondo sono per principio escluse. La pandemia da Covid-19 ha portato acqua al mulino delle chiusure selettive: mentre le porte sono state aperte il prima possibile ai turisti e ai viaggiatori con le caratteristiche desiderate, la prevenzione del contagio ha fornito nuovi argomenti per il respingimento dei rifugiati, per l’imposizione di quarantene, per l’esclusione degli immigrati in condizione legale dubbia o irregolare da cure e servizi. Il caso italiano fornisce in questo caso una parziale e controversa eccezione, avendo approvato una misura di regolarizzazione, benché limitata, proprio in relazione alla pandemia e ai fabbisogni di manodopera conseguenti.
Un altro aspetto rilevante delle politiche basate sul binomio immigrazione-sicurezza concerne lo sforzo d’integrazione tra controlli esterni e interni. I controlli esterni riguardano la sorveglianza dei confini e le misure collegate, come le politiche dei visti, gli accordi di riammissione, la cooperazione con i paesi di transito e la pressione sui vettori internazionali. I controlli interni invece attengono a quattro ambiti: l’esclusione dai servizi pubblici, come l’edilizia sociale o le cure mediche non urgenti; le misure d’identificazione; la detenzione ed espulsione degli immigrati in condizione irregolare; i controlli sul mercato del lavoro. Sono in generale più difficili da attuare, perché colpiscono interessi propri della società ricevente (come le attività economiche), possono minacciare diritti fondamentali (come il diritto alla salute o alla protezione internazionale), e richiedono la cooperazione di altri attori, come le autorità locali, i servizi di welfare e i professionisti di questi settori. Anche in questo campo tuttavia i governi dei paesi dell’UE hanno assunto con un certo successo diverse iniziative per escludere, espellere, scoraggiare gli immigrati non autorizzati, benché un certo numero di governi municipali abbia manifestato un impegno in direzione dell’accoglienza, collegandosi idealmente al movimento statunitense delle “Città santuario”.
Malgrado queste eccezioni, la politica complessiva si rivela quindi sbilanciata in favore degli obiettivi securitari, con un’enfasi sulla lotta contro l’immigrazione non desiderata, in cui rientra di fatto anche l’arrivo di persone in cerca di asilo. Combattendo i trafficanti, come sostengono i governi e le istituzioni europee, si impedisce di fatto l’ingresso di persone che avrebbero titolo per ottenere una delle diverse forme di protezione internazionale. Se per le politiche statunitensi sotto Trump Alexandro Portes ha potuto parlare di “fine della compassione”, l’UE a sua volta ha visto offuscarsi il suo impegno umanitario.
In questo quadro regolativo emerge un paradosso. Una ragione spesso invocata per il rafforzamento delle misure di sicurezza nei confronti dell’immigrazione riguarda la minaccia rappresentata da flussi migratori “incontrollati”. Tuttavia mentre i flussi di richiedenti asilo e altri tipi di ingressi sono soggetti ad attente procedure d’identificazione e controllo, le migrazioni meno controllate sono in realtà quelle interne all’Unione Europea. E’ stata una decisione squisitamente politica, anche se premiata in seguito da una rappresentazione culturale consonante, quella secondo cui gli immigrati provenienti dai paesi dell’Est recentemente aggregati all’UE sono stati riconosciuti nel giro di alcuni anni come cittadini europei mobili, con pieni diritti di circolazione nello spazio comunitario: una politica migratoria non dichiarata come tale.
Il referendum britannico sulla permanenza nell’UE a suo modo ha colto il paradosso, ponendo proprio il controllo dell’immigrazione intraeuropea al centro della contesa. Gli elettori britannici hanno votato per restituire il controllo sugli ingressi alle autorità nazionali del proprio paese, e nello stesso tempo hanno rovesciato l’ortodossia liberale dell’UE sulla mobilità interna delle persone: i cittadini provenienti dalla periferia dell’UE sono stati definiti nuovamente come immigrati, il loro status legale è stato nettamente distinto da quello dei cittadini britannici, le loro domande d’ingresso sono destinate a essere vagliate secondo criteri di corrispondenza con i fabbisogni del Regno Unito e a essere poste in concorrenza con quelle dei candidati provenienti da altre regioni del mondo.
Rispetto a tutto questo, la possibilità d’ingresso per i profughi ucraini, la possibilità di circolare liberamente nell’UE e scegliere dove insediarsi, l’immediata ammissione al mercato del lavoro e a tutti i principali servizi sociali, rappresentano una novità di notevole significato. Forse l’unica buona notizia di queste cupe settimane di guerra.