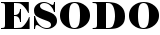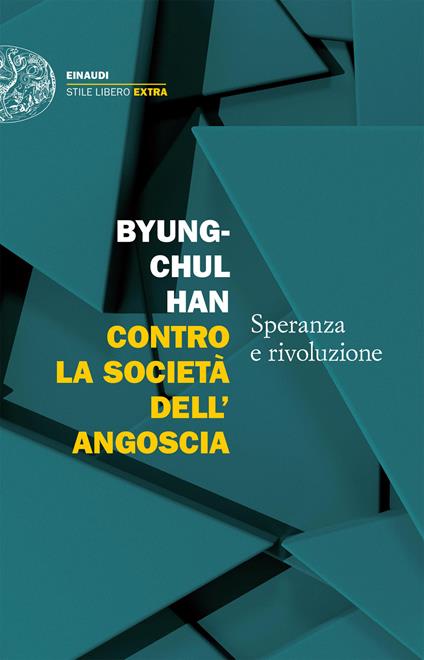Contro la società dell’angoscia
di Byung-Chul Han
Einaudi 2025
È la speranza al centro dell’ultimo volume di Byung-Chul Han, filosofo di origine sud coreana, con alle spalle una formazione nelle università tedesche di Friburgo e Monaco di Baviera, dal 2012 docente presso la Universität der Kunste di Berlino, uno dei principali animatori del dibattito pubblico europeo.
La capacità – rara – di Han è quella di fondere intenzione divulgativa e ricerca, di intessere intorno ai principali nodi della nostra contemporaneità una rielaborazione culturale e filosofica. E di condensare tali operazioni in volumetti agili, ben disponibili alla lettura anche di un pubblico non specialistico. Tale era stato il precedente Infocrazia sulle distorsioni dell’informazione nell’epoca del capitalismo della rete, tale è quest’ultima fatica, che esplora e mette a tema un concetto – la speranza – forse tenuto di lato dalla riflessione filosofica novecentesca (con l’eccezione del Principio speranza di Bloch).
La prima cosa da osservare è che, probabilmente, la resa in italiano del titolo dell’opera non rende conto della sua intenzionalità, e che conviene andare all’originale tedesco per collocare il senso di questo volume. Già, perché se nell’edizione italiana il termine “speranza” è collocato a guisa di sottotitolo, è nell’originale titolo Der Geist der Hoffnung – letteralmente lo spirito della speranza – che essa ritorna al centro.
Perché l’opera di Han in effetti è esattamente questo: un’indagine per andare al cuore di un concetto chiave per ridare respiro a una contemporaneità altrimenti contraddistinta dalla disillusione e dalla frammentazione. Beninteso, nell’evocare la speranza come fondamento distintivo dello sguardo dell’uomo sul contemporaneo, Han non indulge a letture banali o superficiali, bensì ne ridetermina filosoficamente l’essenza.
Del resto, fin dall’inizio del testo è chiara l’intenzione di Han di offrire all’uomo contemporaneo un’alternativa alla condizione che oggi sembra dominare le società, quella dell’angoscia, ben esemplificata dall’immagine dell’”orologio dell’apocalisse”, ideata nel 1947 dalla rivista “Bullettin of atomic scientist” dell’università di Chicago che, ad inizio del 2025, collocava l’umanità a 89 secondi della propria fine.
Per operare tale rielaborazione l’autore ricorre inevitabilmente al dialogo e al confronto con altri grandi autori del pensiero filosofico otto e novecentesco, da Nietzsche a Gabriel Marcel, da Hanna Arendt a Enrst Bloch fino ad arrivare a Martin Heidegger.
E quindi, a partire dalla “delicata bella temerarietà” con cui Nietzsche, in Umano, troppo umano coglie la speranza ergersi al di sopra del ruscello repentino e precipitoso della vita, Han dispiega un confronto dialettico con le principali voci del pensiero filosofico, talora attingendo a esse, talora ricostruendo in autonomia una possibile chiarificazione della speranza come atto fondamentale e orientativo dell’uomo.
Perché al fondo della riflessione di Han sta l’affermazione dell’apertura come carattere essenziale della speranza, e quindi come modalità essenziale per dare scacco al ripiegamento su di sé che contraddistingue la nostra società.
L’apertura di cui la speranza è foriera è contemporaneamente apertura all’altro da sé, ma soprattutto apertura al futuro come dimensione fondamentale del non-già e del non-ancora che però dà senso all’agire. Proprio per questo la speranza è generativa di legame sociale, porta con sé un’attitudine alla relazione, recuperando le parole di Gabriel Marcel: "Io spero in te per noi: questa è forse l’espressione più adeguata e più elaborata dell’atto che il verbo sperare traduce in maniera ancora confusa e velata”.
Il tentativo di Han va al cuore della costruzione del sistema filosofico. Infatti, se la speranza si nutre del non essere ancora, e come tale muove, sprona l’uomo ad agire e a conoscere, ne viene riorientato il senso stesso della filosofia: essa non è più, come nella grecità, anamnesi; neppure può più essere – come preconizzava Hegel – la nottola di Minerva che spiega il suo volo sul fare della sera. Riletta alla luce della speranza, la filosofia stessa si fa pensiero aurorale, in grado non già di conoscere il già stato, bensì di anticipare il non ancora conosciuto.
Nell’ultima parte del volume, Han indaga la possibilità della speranza come “forma di vita”, ingaggiando un corpo a corpo dialettico con Martin Heidegger e la sua analitica esistenziale. Per Han la speranza è la tonalità emotiva fondamentale che caratterizza l’essere umano e, in questo, si discosta dall’analisi heideggeriana che coglieva invece nell’angoscia il tratto caratterizzante dell’esserci dell’uomo.
In questo senso, l’angoscia tradisce il limite essenziale dell’approccio del filoso tedesco, perché se è quest’ultima che consente di disvelare l’essenza dell’uomo, essa si traduce in realtà come rammemorazione di ciò che è già stato e non mai come apertura all’altro. Non a caso l’angoscia, in Heidegger, consente la possibilità anticipatrice dell’essere-per-la-morte come essenza ultima. Come sostiene Han, “l’angoscia è, in ultima analisi, angoscia per la morte”. Ma il pensiero della speranza, prosegue il nostro autore, “non si orienta grazie alla morte, ma grazie alla nascita”, perché “non l’anticipazione della morte, ma l’anticipazione della nascita è l’andatura del pensiero che spera”.
Non v’è dubbio che in questa disamina filosofica Han traccia anche un possibile sentiero concreto, etico, per l’umanità di oggi. Perché giustamente egli coglie l’angoscia come il tratto caratterizzante la nostra epoca; un’angoscia che assume, all’interno del capitalismo delle reti e del neoliberismo, i tratti di uno strumento di dominio che, come il volto di Medusa, paralizza e rende possibile ogni libertà.
Proprio per questo, solo la speranza è in grado di orientare, di rimettere in cammino, di prospettare i semi di una possibile alternativa. Ecco, il pregio di questo agile volumetto sta proprio nel coniugare la perizia dell’indagine e del metodo filosofico con la sua accessibilità e, soprattutto, con la chiarezza del suo messaggio, che intende ricostruire la speranza come la virtù da praticare in questo tempo, anche in “direzione ostinata e contraria”.
Naturalmente molte sono le suggestioni, i percorsi, le riflessioni svolte da Han nel suo volume, e quanto sopra detto ne restituisce solo in minima parte l’ampiezza. Sono le impressioni di un lettore tra tanti, ma possono forse suscitare la curiosità di approcciarsi a questo testo e al suo autore.
di Gabriele Scaramuzza
Byung-Chul Han
Contro la società dell'angoscia
Einaudi 2025, pp. 112, euro 13,00