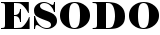di Maurizio Ambrosini, in "Avvenire" dell'11 luglio 2025
«Volevamo delle braccia, sono arrivate delle persone». Il famoso aforisma dello scrittore svizzero Max Frisch si riferiva agli emigranti italiani, ma il problema oggi torna più che mai attuale, in tempi di ripresa della domanda di manodopera straniera nelle economie sviluppate, e in Italia di rinnovato decreto-flussi, con numeri record di nuovi ingressi previsti. Abbiamo bisogno di braccia, ma insieme alle braccia arrivano persone, con la ricchezza e la complessità delle loro esigenze, aspirazioni, legami sociali. Le due richieste più importanti, e mal accette dalle società riceventi, sono i ricongiungimenti familiari e la libertà di culto. Entrambe contribuiscono all’integrazione degli immigrati: favoriscono una vita più serena, pacifica e ordinata. Ma entrambe si discostano dall’ambizione di poter disporre di un’immigrazione “usa e getta” da parte dei governi ospitanti.
La vita in famiglia aiuta a superare solitudine e disorientamento, accresce le relazioni con il contesto grazie ai figli, induce stabilità e normalizzazione degli stili di vita. Ma la stabilità significa radicamento, la scolarizzazione dei figli (930.000 alunni stranieri in Italia) vuol dire mescolanza, la crescita dei nuclei familiari comporta domanda di case e servizi. Così governi e opinione pubblica chiedono agli immigrati di lavorare e d’integrarsi, ma resistono all’idea di favorirne quella dimensione familiare che faciliterebbe entrambi i compiti. In Italia il governo ha raddoppiato, da uno a due anni, il tempo necessario per richiedere il ricongiungimento familiare, oltre alle condizioni di reddito e di idoneità abitativa già previste. Anche la pratica religiosa favorisce l’integrazione. Un’ampia ricerca internazionale l’ha definita “balsamo dell’anima”: come un tempo per gli emigranti difesi da Leone XIII nella Rerum Novarum, anche oggi gli immigrati trovano presso i luoghi di culto la forza per reggere lo sradicamento e la fatica di ricostruirsi una vita all’estero.
Recuperano risposte alle domande esistenziali. Tessono legami di solidarietà. Ma come accadeva un tempo agli emigranti cattolici, anche oggi le loro forme religiose non piacciono a governanti e opinionisti. Il governo del pluralismo religioso è una sfida complessa, richiede negoziati e accordi, trasparenza e promozione degli interlocutori più affidabili.
L’Islam, come è noto, è lo scoglio più arduo, anche se non l’unico. Ma lo sforzo di dialogo, che aveva ottenuto buoni risultati con il governo Gentiloni, ora si è interrotto. Così in Italia l’Islam (1.700.000 seguaci stimati) resta semi-sommerso. In tutto il Paese esistono 5 moschee riconosciute e riconoscibili (con cupola e minareto); una trentina non riconoscibili (senza cupola e minareto) ma riconosciute a livello locale come luoghi di culto; oltre 1.200 centri culturali islamici dotati di una sala di preghiera, ma non riconosciuti e poco tollerati. Il caso di Monfalcone è ancora una volta emblematico. Una città la cui economia dipende sempre più dal lavoro immigrato, richiesto dall’industria cantieristica, ha un governo locale che non perde occasione per sollevare conflitti con gli immigrati, soprattutto sul piano religioso.
L’ultima è la chiusura di una sala di preghiera. Le norme urbanistiche vengono utilizzate contro un diritto umano fondamentale come quello della libertà religiosa. Siamo importatori riluttanti di lavoratori immigrati: ne abbiamo bisogno, ma non vorremmo integrarli. Prima usciremo da questa ipocrisia, tanto meglio sarà per la coesione sociale, la sicurezza, il benessere della società tutta.