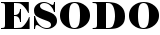Luciano Bano, frate e presbitero francescano, se ne è andato improvvisamente nell’altra vita. Accanto all’istantaneo dolore che la notizia ha provocato nei molti che lo hanno conosciuto nelle sue diverse peregrinazioni territoriali ed esperienziali, ugualmente immediati sono comparsi ricordi di incontri, di parole, di abbracci avuti con lui, associati dal suo sguardo apparentemente ingenuo accompagnato da un sorriso che esprimeva amicizia, curiosità e fiducia.
Luciano, fedele amico di Esodo nella sua espressione associativa e nell'attenta lettura dell'unita rivista, ha percorso un lungo e intenso periodo della sua vita come operatore sanitario in un ospedale mestrino facendo parte di quel significativo gruppo di “preti operai” presenti nell’area veneziana che sono stati testimoni di appartenenza alla Chiesa vissuta entro la condizione e le battaglie della classe operaia.
La rivista Esodo nel 2009 ha dedicato una monografia a tale esperienza (Preti operai nel veneziano supplemento/2009) dove anche fr. Luciano racconta motivi e significati della sua scelta di impegno nel mondo lavorativo.
In ricordo di questo nostro amico riportiamo di seguito il testo del suo racconto.
Quali sono state le motivazioni della tua scelta di andare a lavorare? Come sono maturate e con chi? Quali le esperienze di lavoro?
Ho deciso di andare a lavorare nel 1973, dopo una maturazione personale che è durata quasi un anno. Erano 7 anni che stavo nel patronato della chiesa del Sacro Cuore a Mestre. Fin dall’inizio mi sentivo a disagio, uscito dal seminario con tutta l’idealità del Concilio che in quegli anni pensavamo iniziasse a trovare realizzazione. Invece mi sono trovato di fronte ad un patronato che era solo per i ragazzi che andavano a messa, mentre gli altri non potevano entrare. Poi il parroco mi ha lasciato fare e ho cambiato. Si era costituito un bel gruppo di giovani, dai 18 ai 25 anni, fino a circa un centinaio. Con loro abbiamo fatto una forte discussione sul senso del patronato, della chiesa, dei frati francescani. Sono andato in crisi quando è stata costruita la chiesona immensa, finita nel ’70. Mi trovavo come francescano e come membro di quella comunità ecclesiale di giovani, che maturava un’idea diversa di chiesa piena di grandi strutture, impegnata a ingrandire se stessa. In questa chiesa che posto ha il Vangelo? Che non apre a Cristo, ma che nasconde, copre il Vangelo. Una chiesa per se stessa, come una società civile che si organizza. In particolare il mio disagio veniva dall’essere francescano, che annunciava la povertà, la semplicità, e vedeva invece crescere le grandi strutture. Mi chiedevo allora che senso avesse essere francescano in questa situazione. Dovevo annunciare la povertà e difendere una chiesa che enunciava principi senza applicarli. Ne parlavo con i giovani, che mi incoraggiavano nella mia scelta, leggevo i documenti dei preti operai. Andar via è stata una scelta personale. Pensavo di ritirarmi per un periodo a casa mia, o di andare a Spinea, dove c’era anche un’esperienza di comunità di preti e di chierici operai. Mi hanno proposto di andare nella comunità francescana che si era formata a Marghera, in Via della Pila. Ho accettato di vivere in questa comunità, ma chiarendo subito che avrei cercato un lavoro, perché la povertà non è non avere soldi (e quando si ha bisogno si va a prendere quanto serve...). Povertà è invece uno stile di vita, il mantenersi lavorando.
Quando ho lasciato la parrocchia mi è stato intimato di non mantenere nessun rapporto con le persone della comunità. Sono stati chiusi alcuni gruppi e iniziative di giovani. Ad esempio, gli incontri con esponenti delle altre fedi cristiane.
Ho trovato subito un lavoro provvisorio ai Mercati Generali di via Torino a Mestre. Era molto faticoso, non solo per l’orario, ma proprio fisicamente. Io non ero abituato e non avevo un fisico adatto. Bisognava essere là alle 3 o 4 del mattino. Allora ho cercato un lavoro a Marghera. Ma quasi tutti i direttori delle aziende mi conoscevano, perché frequentavano la parrocchia del Sacro Cuore. Mi stimavano molto per quanto avevo fatto per i loro figli e non volevano che entrassi in una fabbrica. Sono allora riuscito a farmi assumere in un ospedale, il Policlinico San Marco, come ausiliare infermiere. Sono rimasto fino alla pensione, a 65 anni, nel 2005. Ero in terapia fisica, ho studiato come fisioterapista e ho frequentato la scuola infermieri professionali. Era un periodo di lotta con la direzione anche perché avevamo costituito il sindacato. Il direttore ha scritto al Patriarca Luciani chiedendo che mi togliesse dal lavoro e si impegnava a pagarmi lo stesso. Sapeva che vivevamo in quattro, con i due stipendi di quelli che lavoravano. Il Patriarca ci ha passato la lettera dicendo che decidessimo noi. Ho continuato a fare i lavori più umili, anche se avevo il titolo per fare qualcosa di diverso. Alla mattina si puliva e poi si cominciava a fare il fisioterapista o l’infermiere…
Ero impegnato nella CISL e siamo riusciti a costruire il sindacato ospedalieri, cambiando segretario provinciale.
Hai continuato a vivere nella comunità dei francescani, in cui due erano cappellani del lavoro. Che rapporti avevate, considerando che la vostra di preti operai era una scelta molto diversa?
Vivevamo nella stessa comunità di Via della Pila a Marghera, due preti operai, io e Mario Faldani, e due cappellani del lavoro, con i quali abbiamo sempre discusso. Le nostre erano però scelte personali, che consideravamo opposte a quelle della pastorale dei cappellani del lavoro. Come gli altri preti operai dicevamo che noi non eravamo “per” ma “con” gli operai, eravamo assieme a loro e cerchiamo di vivere la nostra testimonianza cristiana e anche di sacerdoti se ce lo chiedono. Abbiamo allora deciso che la comunità era formata da una parte dai cappellani del lavoro e da un’altra da frati lavoratori, che portavano lo stipendio per mantenersi e rifiutavano i soldi per le messe e quanto davano la diocesi e la Provincia francescana. Non volevamo vivere del sacro. Gli altri due frati si sono divisi le fabbriche. Cercando di discutere assieme, anche loro hanno cambiato mentalità e non andavano solo per la San Vincenzo e per le messe, ma hanno cominciato a inserirsi nella fabbriche vivendo momenti significativi con i lavoratori (mensa, ristrutturazioni...) e seguendo casi singoli. Noi preti operai ci incontravamo sempre nella nostra casa, si manteneva così un legame anche con i cappellani del lavoro.
Che rapporti avevi nell’ambiente di lavoro, in particolare con gli altri lavoratori?
All’inizio non dicevo di essere prete, ma in ospedale venivano molte persone che mi avevano conosciuto in parrocchia e quindi si è saputo che ero prete. Mi hanno eletto delegato sindacale del reparto. Il mio impegno era scoprire il Vangelo all’interno dell’ambiente di lavoro. Cercavo di viverlo e di testimoniarlo, portando avanti con gli altri il senso della giustizia, dell’egualitarismo, dell’amicizia, della fraternità. Mi battevo per questi che per me erano i valori evangelici da scoprire nell’ambiente dove mi trovavo. Davo una mano per evitare che si lottasse solo per interessi personali, guardando invece all’interesse di tutti, in particolare dei più deboli. Si era formato un bel gruppo come sindacato, che portava avanti l’egualitarismo, sul quale la CGIL non era all’inizio molto d’accordo, ma poi è stata una delle battaglie più grosse con i contratti contro la piramide sociale e salariale. Così si combatteva contro le ingiustizie presenti nel lavoro. Potevo scoprire il Vangelo meglio in questo ambiente che in quello della parrocchia dove ero prima. Non ero al di sopra ma uno di loro, e assieme si cercava di scoprire il Vangelo. Questa era la mia testimonianza. Io rimanevo disponibile, se qualcuno mi chiedeva di fare un percorso assieme, quando, ad esempio, si sposavano o per i battesimi. Mi avevano anche detto di fare il cappellano dell’ospedale. Avrei avuto vantaggi perché avrei avuto dall’ospedale uno stipendio da dirigente, come erano inquadrati i cappellani.
Come erano i rapporti con gli altri francescani e con la diocesi?
La Provincia francescana mi aveva proibito di avere impegni nel sindacato. Ogni incontro si discuteva e alla fine è stato tollerato che io continuassi. Ma è stato uno dei motivi per cui nel 2003 siamo stati mandati via dalla casa di via della Pila, dove ora non c’è più nulla. Per tutto il periodo, visto che non cedevamo, ci hanno ignorato. La curia diocesana ha creato problemi. Il Patriarca Luciani ci ha impedito di fare gli incontri con i preti operai presso di noi. Siccome le riunioni continuavano, non è più venuto come prima, quando faceva le visite alle fabbriche. Il Patriarca Cè diceva che non capiva la nostra posizione. Rispettava la nostra, ma solo come scelta personale, non come attività della pastorale diocesana in cui rientravano pienamente i cappellani del lavoro. Vedeva la nostra come un’attività non confacente con quella del prete che doveva essere disponibile a tempo pieno, in particolare in quel momento in cui c’era molto bisogno di preti e lo stipendio era garantito dallo Stato. Ma era proprio questo il problema che ponevamo, rifiutando l’8 per mille. La nostra non era una scelta ideologica, di principio astratto, ma essenzialmente evangelica e, per noi, francescana. Inoltre volevamo essere totalmente indipendenti dallo Stato che inevitabilmente condiziona, in cambio dei finanziamenti.
Pensi, ora che hai finito questa esperienza, che le motivazioni e i problemi posti rimangano attuali o siano superati, legati alla contingenza storica di quel particolare momento?
I nodi posti dai preti operai riguardano prima di tutto la necessità di condividere la condizione delle persone nei loro stessi ambienti di lavoro, in cui è possibile scoprire il Vangelo molto meglio che nelle strutture della chiesa che fanno da velo al Cristo. La chiesa lo nasconde perché vuole crescere come società, vuol far proseliti invece di condividere un cammino di fede per capire assieme l’annuncio del Vangelo, cosa significhi aderire a Cristo.
Capisco che nella chiesa si avesse paura di essere compromessi in quelle che venivano considerate ideologie contrarie alla chiesa, e quindi, ad esempio, con i sindacati come la CGIL e parte della CISL. Si viveva un clima di scontro e noi eravamo visti come un pericolo perché sospettati di cedere a queste ideologie. Io dicevo che non mi impegnavo nel sindacato per motivi ideologici, ma ho sempre scelto in base a come venivano posti i problemi concreti della vita dei lavoratori.
Anche noi però abbiamo rinunciato al confronto con il nostro atteggiamento. C’era una contrapposizione. Di fronte ad una chiesa che si difendeva, non capiva, noi dicevamo che eravamo al confine e, all’inizio, cercavamo di affrontarla per vedere se riusciva a capire le nostre scelte che dicevamo coerenti con il Concilio. Invece la chiesa si difendeva, ma forse non l’abbiamo aiutata a riflettere. Noi stessi ci siamo chiusi in noi stessi, eravamo contenti di stare fermi nel confine. Ci siamo messi in contrapposizione, affermando le nostre posizioni alternative che volevano rinunciare ai finanziamenti del Concordato, alle proprietà, ai soldi delle funzioni… Il nostro atteggiamento era visto come mettere in discussione la struttura stessa della presenza della chiesa, mentre noi volevamo far capire che la chiesa non era la nostra fede, ma deve essere uno strumento per giungere a Cristo. Invece era un frapporsi tra Cristo e la comunità di fede.
C’era anche una difficoltà con le strutture francescane. La nostra comunità che non chiedeva soldi alla Provincia francescana e non ne dava, era vista non legata, non inserita nella comunità francescana. Si vogliono dei sudditi più che dei confratelli. La Provincia ci ha sempre rimproverato la nostra estraneità. Noi volevamo invece fare esperienza come una famiglia normale. Ci accusavano di essere aperti a tutti. Noi avevamo deciso di dare a ciascuno di noi una cifra al mese, con la quale dovevamo mantenerci. Ciascuno doveva fare i suoi conti, come in una famiglia normale, senza chiedere quando pensavamo di aver bisogno. Lo spirito del Vangelo non è annunciare la povertà e poi saper di poter sempre chiedere soldi.
Adesso che ci sono meno vocazioni, meno strutture, che restano vuote, c’è un ripensamento nelle comunità francescane? Vedi la possibilità di un confronto positivo nella chiesa?
Noi dicevamo che si doveva dar via queste strutture. Oggi ci sono molti soldi e si fanno costose ristrutturazioni, si aiutano le comunità che hanno meno. Ma significa che si hanno molti soldi, molte entrate, che restano però sempre all’interno. Se c’è una comunità povera, si dovrebbe ringraziare il cielo. Perché aiutarla a diventare ricca? Diventa distribuzione della ricchezza all’interno, sempre in modo autoreferenziale. Ora mi sento molto a disagio. Mi sembra che la chiesa stia facendo molto spettacolo, dove i giovani sono spettatori. Cosa resta? Non credo si aiuti a riflettere con iniziative molto appariscenti, con poca semplicità. Si presenta o si nasconde il Vangelo? Si mette in evidenza la persona o la struttura? Fino a che punto si aiuta a riflettere, a vivere la testimonianza? Diventano brave quelle parrocchie che si inventano novità per attirare, spettacolarizzare. Manca la semplicità, l’umiltà, la povertà anche dei mezzi. Un giovane si avvicina a Cristo se io non mi metto davanti; se lo faccio per attirarli, una volta che vado via, cosa resta? Il prete nasconde Cristo, copre il suo messaggio? Mi dico che sono nostalgico. È difficile parlare, perché sembra giudizio, critica non costruttiva. Forse bisogna ripartire con piccole esperienze, senza il conforto dei grandi numeri. Nostro compito dovrebbe essere quello di far emergere il bisogno di profondità, di amicizia, di fare un cammino di fede, invece copriamo il loro desiderio di spettacolo, di avere belle chiese, tante attività, di farsi così alti da coprire Cristo. D’altra parte penso a come sono finite le varie comunità fondate da San Paolo... Così moriranno tante chiese, ma Cristo continuerà.