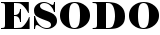Riflessioni sull’orizzonte antropologico dell’economia
di Roberto Mancini
- L’antropologia interculturale della dignità
Nelle pagine che seguono vorrei approfondire la questione del profilo antropologico che orienta la cultura dell’economia vigente, incentrata com’è noto sulla figura dell’homo oeconomicus. In questa concezione opera una sostituzione della stima per l’umanità con una sorta di disprezzo aprioristico, per cui l’uomo per natura sarebbe autointeressato, aggressivo e calcolatore.
L’esito attuale di questa disistima è che nella rudimentale antropologia del sistema economico globale oggi imperante agli esseri umani non è lasciata altra possibilità all’infuori di quella di essere risorse, quando va bene, o esuberi, quando va male, oppure scarti, quando va nel peggiore dei modi. Il sistema vigente non vede le persone, non vede l’umanità, non vede il mondo vivente.
L’intuizione antropologica originaria è decisiva per imprimere questa o quella direzione alla concezione dell’economia, la quale non ha nulla di “naturale” nel senso che ogni volta è la risultante di un’elaborazione culturale che poteva e può anche essere profondamente diversa. Credo che la stima per l’uomo e la memoria della sua dignità, dunque anche la considerazione del suo legame ontologico con la natura (che non è riducibile a una cornice chiamata “ambiente”) come realtà originaria di valore, siano una luce indispensabile per pensare l’economia sin nei suoi aspetti più specifici e concreti. Se manca questa luce, l’economia diventa immediatamente un sistema particolarmente efficace di perpetrazione della violenza.
Una coscienza adeguata al compito di orientare l’economia non possa essere il parto di qualche cultura particolare; piuttosto deve scaturire da un’effettiva convergenza interculturale, interfilosofica e interreligiosa tra tutte le sapienze antropologiche del mondo. Se si fa un’indagine di questo tipo, si resta colpiti da due cose. Primo: nessuna di tali tradizioni si è mai sognata di raffigurare il soggetto umano con il profilo dell’homo oeconomicus, che da questo punto di vista risulta notevolmente anomalo e arbitrario. Secondo: tutte le sapienze antropologiche convergono nell’indicazione di alcuni tratti umani costitutivi e irriducibili, cosicché se li si nega o li si deforma si cade nella disumanizzazione. Una simile consapevolezza fu inaugurata già dalle intuizioni di quella che Karl Jaspers ha chiamato l’epoca assiale della storia, tra l’800 e il 200 a. C., quando in diverse aree del mondo e secondo percorsi autonomi - in particolare in Cina, in India, in Persia e in Europa - emerse il riconoscimento di questi valori inscritti nel modo umano di stare al mondo.
Esplicito sinteticamente questi tratti costitutivi, formulati nell’antropologia della dignità; essi esprimono la costellazione dei modi d’essere essenziali inerenti all’essere umano: l’unicità, cosicché in ogni cultura il singolo è irriducibile a una cosa, a un mezzo, a un disvalore, a una “parte” sacrificabile della totalità sociale; la relazionalità, per cui la vita di ognuno è intrecciata con quella di tutti; l’apertura, che porta l’essere umano a cercare un valore e una realtà più grandi della mera sopravvivenza (Dio, il divino, l’infinito, il bene, la verità, la bellezza); l’integrità, che vale come armonizzazione di un essere policentrico quale la persona è, mentre nella scissione nessuno è se stesso; la responsabilità, categoria esecutiva e dinamica fondamentale, che include in sé facoltà essenziali come la coscienza, la libertà, la creatività storica.
- Ontologia della gratuità
Se si allarga la prospettiva sino a considerare la percezione del mondo, della vita e della realtà, si delinea un’intuizione trasversale e ricorrente che può essere designata nella formula di ontologia della gratuità. Qui il termine “ontologia” è assunto nel senso più aperto possibile: non è una teoria dell’essere primo o dell’origine, è un riconoscimento della realtà, dell’unico mondo in cui siamo una sola umanità. Ebbene, in questa visione variamente elaborata nelle diverse culture e religioni, la vita è concepita come dono e ognuno è chiamato a riconoscersi come dono affidato a se stesso, in un’autorelazione che rimanda non all’ordine della proprietà e alla logica dell’autoreferenzialità, ma all’ordine della responsabilità.
Il dono è unico per ciascuno e nel contempo accomuna tutti i viventi, cosicché la vita stessa è pensabile come una immensa comunità, dove l’isolamento radicale è morte, mentre la pienezza della vita e comunione. L’interdipendenza e la coralità sono leggi vitali che è sì possibile trasgredire, ma sempre pagando il prezzo del porsi in una dinamica autodistruttiva. Ognuno di noi è come un filo unico, di inestimabile valore, partecipe di un tessuto che è fatto dell’intreccio di tutti gli esseri. Pertanto non si può privatizzare la vita, né la si può inglobare nell’economia, perché la sua relazionalità essenziale smentisce qualsiasi individualismo e la sua originaria costituzione nella gratuità trascende ogni sistema di organizzazione economica.
Anche qui bisogna precisare che il rimando alla gratuità non va piegato nel senso di una idealizzazione per cui tutto è bello e la felicità è una condizione primigenia. Più concretamente occorre vedere che la gratuità implica una fragilità: senza cura essa decade, viene sprecata e soffocata. Quando Nicholas Georgescu-Roegen pensava a una bioeconomia, ossia a un’economia capace di amicizia con la vita del mondo, aveva la consapevolezza di come il lato della fragilità comportasse nell’interazione tra processi naturali e lavoro umano il vincolo dell’entropia: la dispersione irreversibile di energia e l’aumento del disordine.
Non si tratta di un principio di morte che ha la meglio sulla vita, si tratta del vincolo per cui ogni dinamica di dono e di relazione tra viventi ha bisogno della cura, dell’impegno all’armonizzazione, alla riparazione, al riequilibrio, al risanamento e questo impegno dev’essere permanente. Dalla sfera delle microrelazioni familiari, amicali e comunitarie sino a quella delle relazioni sociali e interetniche, il senso ispiratore dev’essere quello della libera reciprocità tra i soggetti coinvolti e non quello della complementarità tra chi domina e chi è dominato, come sottolinea Jessica Benjamin.
La conseguenza di questa consapevolezza ontologica, antropologica e scientifica determina l’approdo a un’etica del bene comune. Si chiarisce a questo punto come l’autocoscienza antropologica esiga un dialogo costante tra ragione e coscienza; senza l’intervento di quest’ultima, la ragione cade in una spirale raziocinante cieca nei confronti dei valori viventi e della differenza tra degno e indegno, creativo e distruttivo, bene e male.
- L’etica del bene comune e della democrazia
Il termine “etica”, come ha mostrato Emmanuel Lévinas, non può valere semplicemente per designare una serie di regole e magari di divieti. Nella sua radice esso allude al dovere di imparare ad abitare insieme senza distruggerci e senza distruggere il mondo. Etica è coabitazione del mondo. È il risveglio delle coscienze alla responsabilità per la sorte degli altri e della vita comune. È impegno con quel bene che si dà lì dove umanità e natura possono fiorire, di contro al male che è distruzione e menzogna, rovesciamento e pervertimento della realtà. Diventa chiaro allora che l’etica che qui ci interessa non può essere ricavata da una certa tradizione dell’umanità, senza le altre, né può rispecchiare un’identità particolare. Dev’essere un’etica universalmente plausibile e vincolante, per cui non si scommette mai sul potere, sull’esclusione, sulla sconfitta degli altri, né su altra competizione che non sia la lotta interiore per vincere il male in se stessi.
Solo una forma mentale da lungo tempo abituata a scomporre ciò che è unito poteva ipotizzare che il bene e il giusto siano separabili; in realtà essi si alimentano l’un l’altro. Il bene è la realtà di valore fondamentale che concretamente sostiene la vita delle persone, delle collettività e del mondo, mentre il giusto è il valore dinamico la cui attuazione deve fare in modo che il godimento del bene sia universale e non discriminatorio, cosicché esso sia in effetti bene comune.
Il territorio di una comunità umana è senz’altro il luogo civile e geo-storico essenziale per formarsi all’esperienza del riconoscimento e della cura del bene comune. Si tratta d’altronde di apprendere che i confini del bene comune e della relazione con i soggetti con i quali si ha un legame etico non coincidono con quelli di una certa località. Infatti occorre capire che non è mai l’appartenenza etnica o geo-culturale a generare la comunità; semmai è la comunità effettiva, aperta e ospitale, che interagendo con la natura genera la specificità e il respiro del territorio. In tal senso, come aveva intuito Adriano Olivetti, le relazioni comunitarie aperte, solidali, ospitali sono il tessuto vitale di una società democratica, dove ogni territorio può vedere riconosciuto il suo valore. L’etica del bene comune è l’orientamento normativo e finalistico delle Costituzioni democratiche.
A sua volta, ciò che chiamiamo “comunità” non dipende dall’affinità, dalla comunanza di lingua e di luogo, ma anzitutto dalla coscienza collettiva della dignità delle persone e della responsabilità per la porzione di mondo che ci è affidata. Non c’è comunità senza apertura all’universalità della comunità umana e dei viventi. Non c’è comunità senza accoglienza, ospitalità e disponibilità alla corresponsabilità per il destino della terra. Altrimenti l’appello al “territorio” diventa facilmente il pretesto o per ideologie localiste, xenofobe, razziste, leghiste, che rappresentano una tendenza contraria all’autentica vitalità della comunità umane e alla democrazia come forma di convivenza umanizzata, o per ripiegamenti autoreferenziale dove si dice “comunità” e si intende “rifugio”.
L’attuale presunta alternativa, mistificante e smaccatamente ideologica, tra il globalismo dei poteri semi-automatici dominanti (mercato e finanza, sistema tecnologico, sistema mediatico, sistema burocratico e sistema geopolitico-miliare) e il sovranismo nazionalista e razzista che oppone “la gente” alla “casta” è una trappola. Si tratta dei due versanti della stessa logica di potere antitetica allo sviluppo della democrazia in tutti i rapporti. Con tale formula intendo un ordinamento della vita collettiva dove progressivamente non più il potere a mediare le relazioni, ma sono il servizio e l’autentica autorità, che etimologicamente indica quel riferimento che ti rende autonoma e ti consente di apprendere. Chi oggi in Italia pensa di opporre alla globalizzazione capitalista il sovranismo gialloverde non si rende conto né di come si possa superare il regime della finanziarizzazione del mondo, né dei pericoli del nazionalismo xenofobo e razzista, chiamato “sovranismo” con un ambiguo eufemismo che è già come termine è indizio di una contraffazione ideologica.
In questa prospettiva il “cambiamento” - altro eufemismo opaco e fuorviante - diventa la radicalizzazione o del modello globalista o del modello sovranista. Guarda caso entrambi invocano, con tono intimidatorio, il “cambiamento”, per cui chi si oppone è qualcuno che sta fuori dalla storia ed è superato dai tempi. In realtà un cambiamento senza trasformazione è una truffa. A noi non serve il cambiamento, serva il mutamento di forma della società e dell’economia, ossia una trasformazione che sia la liberazione delle vittime della mancanza di democrazia e di cura del bene comune.
- Il senso dell’economia
Se adesso poniamo la questione del senso dell’economia, credo che esso sia riconoscibile tenendo conto delle coordinate antropologiche e ontologiche che ho appena richiamato. A me pare che il senso dell’attività economica risieda nel compito di qualificare il tipo di risposta, da parte dell’umanità, al dono della vita e della convivenza. L’economia deve contribuire a far sì che tale risposta includa un’organizzazione in grado di sostenere la vita di persone e popoli e di assicurare l’equilibro con il mondo naturale. L’economia è una scienza, una sapienza, un’arte e una pratica della responsabilità collettiva che ha il compito di organizzare le condizioni materiali e sociali della partecipazione collettiva al dono della vita. Solo una economia impazzita, rovesciata, mortifera, può costruirsi sulla tendenza ad accrescere i processi di spreco, di inquinamento e di distruzione, sino a costruire una società entropica, come ha sottolineato Lieven De Cauter.
Un’economia umana dev’essere un’economia sostenibile, dove questo aggettivo va finalmente inteso in senso attivo: un’economia che sostiene la società. Questo compito deriva dalla vocazione etica istitutiva dell’economia stessa: se l’etica indica il compito di abitare insieme il mondo senza distruggerlo e senza distruggerci, l’economia deve allestire le condizioni per dare continuità a questa coabitazione. Il compito etico è insieme politico nel senso essenziale del termine, ossia rimanda alla politica intesa come l’attività di cura del bene comune, protesa a costruire un ordine del mondo capace di “risonanza” con le aspirazioni e con la sensibilità degli esseri umani.
L’economia come sistema organizzativo non ha il compito di dare la felicità, bensì ha quello di combattere le cause materiali e sociali dell’infelicità. Deve evitare che la fame, la sete, il freddo o il caldo eccessivi, la miseria, la precarizzazione, lo sfruttamento, la mancanza di futuro determinino sofferenza, oppressione, disperazione e morte per chiunque. È una funzione di prevenzione, di rimozione e di liberazione rispetto a tutto ciò che nega la dignità e la vita. L’economia non produce una condizione felice; essa semmai deve essere propizia alla felicità. In ogni caso, non può più continuare a essere una sventura che causa la rovina della comunità umana e della natura.