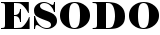di Giuseppe Tattara
Premessa
La guerra economica si riferisce a strategie e azioni intraprese da un paese per danneggiare l'economia di un avversario. Questo può includere sanzioni commerciali, dazi, blocchi economici, cyber attacchi e altre misure che mirano a indebolire la capacità economica di un nemico. L'obiettivo è spesso quello di ottenere vantaggi politici o militari senza ricorrere a un conflitto armato diretto.
L'economia di guerra si riferisce all'organizzazione e alla gestione delle risorse economiche di un paese durante un conflitto armato o a sostegno di un conflitto armato gestito da un paese terzo. In questo contesto, le nazioni possono mobilitare risorse, aumentare la produzione di beni militari e implementare misure per aumentare l'efficienza economica necessaria per sostenere uno sforzo bellico. Questo può includere il razionamento di beni, l'aumento della tassazione e la riconversione delle industrie per produrre materiali bellici.
In sintesi, mentre la guerra economica è una strategia per danneggiare l’ avversario, l'economia di guerra studia come un paese gestisce le proprie risorse durante un conflitto o in vista di un conflitto.
Quando mi è stato chiesto di intervenire sul tema guerra economica ed economia di guerra mi sono chiesto a lungo che legame ci fosse tra i due eventi, al di là della assonanza del linguaggio. Studiando, il legame mi è apparso chiaro. Il conflitto resta il modo principale di regolare i rapporti tra nazioni sovraniste e si può concretizzare in una lotta economica e in una lotta armata.
La globalizzazione ha portato a una maggiore interconnessione e interdipendenza tra le nazioni, erodendo in parte la sovranità degli stati: l'aumento degli scambi, la mobilità dei capitali e delle persone, e la diffusione di nuove tecnologie hanno creato una rete globale di relazioni che trascende i confini nazionali, le istituzioni internazionali come WTO, G7 e G20, Corte penale internazionale e altre hanno tradizionalmente offerto piattaforme di dialogo, hanno permesso la cooperazione e la negoziazione tra gli stati. Ora sono emersi alcuni grandi stati come gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, che agiscono sempre di più in funzione del proprio interesse nazionale
e non riconoscono un quadro giuridico o politico superiore. Allora l'interazione tra stati diventa una competizione costante per l'affermazione di potere: l’intesa si concretizza solo attraverso la prevaricazione o la dimostrazione di forza, e guerre e instabilità divengono la condizione “normale” con cui si regolano i rapporti tra gli stati, negando di fatto ogni valore alla apertura dei canali di dialogo, che avrebbe dovuto essere invece la lezione appresa dalle tragedie del XX secolo.
Guerra economica
I dazi, il deficit e gli obiettivi di Trump. Il proposito dichiarato di Trump è quello di ridurre i disavanzi del saldo merci tra i vari paesi con gli Stati Uniti. Trump interpreta lo sbilancio bilaterale come un sussidio agli altri paesi, che profitterebbero della ricchezza degli Stati Uniti per arricchirsi a loro spese, vendendo più di quello che comperano. Si tratta di una affermazione priva di qualsiasi base teorica. In un mondo multilaterale quello che conta è l’eventuale sbilancio degli Stati Uniti verso tutti gli altri paesi. Il deficit commerciale degli Stati Uniti significa solo che questo paese compera all’estero più di quanto vende. Visto che acquistare significa comparare un bene prodotto da altri, comperare molto all’estero vuol dire che la spesa degli americani genera occupazione all’estero e produzione di reddito all’estero.
Secondo Trump sarebbe possibile produrre gli stessi beni all’interno e generare occupazione negli Stati Uniti e i dazi sarebbero uno strumento efficace per ridurre le importazioni americane rendendole più care; tuttavia il corollario di questa affermazione che riguarda cioè la possibilità di rilocalizzare negli Stati Uniti parte della produzione industriale non è per nulla scontato.
Secondo questa interpretazione la delocalizzazione in Cina e negli altri paesi dell’attività produttiva americana sarebbe l’effetto di una liberalizzazione degli scambi sviluppatasi a svantaggio degli Usa, ma le cose sono andate diversamente.
a) In questi mesi il Presidente Trump ha minacciato dazi molto alti che nel corso di successive negoziazioni sono stati drasticamente ridotti. Ad esempio nei riguardi della Cina si è passati in pochi giorni dal 150% al 35%. Secondo alcuni studi il dazio medio complessivo sulle importazioni degli Stati Uniti è oggi (giugno) del 15.1%, il più alto dal 1938. Il 15% è anche il dazio negoziato sulle importazioni degli Stati Uniti dall’Europa. Storicamente, prima dei recenti aumenti, il tasso medio di protezione statunitense si aggirava intorno al 2.5% - 3% ed è stato a questo livello lungo gli ultimi 50 anni. I dazi su veicoli, alluminio e acciaio sono cresciuti più della media.
b) l’industria manifatturiera oggi negli Stati Uniti pesa 10% sul prodotto interno, molto poco. A determinare il passaggio verso la globalizzazione e la liberalizzazione non è stato il destino ma una strategia delle multinazionali statunitensi che per prime hanno scelto di andare a comprare o produrre merci in Cina e in altri paesi dove i costi sono bassi. A seguito dei dazi sulle importazioni molte di queste multinazionali non tornano in patria ma hanno annunciato di spostarsi altrove (il caso Apple che annuncia di andare in India con iphone e ipad è emblematico).
c) la quota di occupazione manifatturiera degli Stati Uniti è diminuita costantemente dall'inizio degli anni Cinquanta. I grandi cambiamenti nella politica commerciale, come l'approvazione dell'Accordo di libero scambio nordamericano, non hanno accentuato il calo che ha carattere strutturale.
d) la posizione statunitense si è molto indebolita in questi anni sul piano competitivo e questo spiega l’aumento delle importazioni. Tra il 1995 e il 2022, la maggior parte dei Paesi OECD ha ridotto la propria quota percentuale nella spesa globale in Ricerca e Sviluppo. Gli Stati Uniti, ad esempio, sono passati dal rappresentare il 45% della spesa complessiva nel 1995 al 37% nel 2022. I paesi europei hanno fatto peggio: l’Italia ha dimezzato la propria quota, passando dal 3,1% all’1,5%.
La Cina ha incrementato in modo significativo i propri investimenti in Ricerca e Sviluppo, passando da una quota del 2,9% nel 1995 al 34,1% nel 2022 del totale mondiale (a maggior ragione su OECD). Questa combinazione tra forti investimenti produttivi e spesa in ricerca ha spostato la Cina dalla produzione di beni e servizi a basso costo verso settori a maggiore valore aggiunto e ad alta intensità tecnologica (tecnologia dell'informazione, robotica, energia verde e veicoli, aerospazio, ingegneria oceanica e ferroviaria avanzata, nuovi materiali, biomedicina).
e) i dazi hanno dei risvolti negativi perché aumentano i costi per i consumatori americani e aumentano i prezzi (inflazione). I dazi rappresentano un “onere fiscale sugli americani che si calcola sia aumentato di circa il 2% del reddito nazionale negli ultimi mesi”. È un aumento delle tasse (i dazi sono una tassa pagata dal consumatore americano) profondamente regressivo, che genera inflazione, anche se non sempre nel breve periodo.
Nella contesa con la Cina è difficile che gli Stati Uniti abbiano successo. Pechino si prepara da anni, e i cinesi hanno già ridotto (da più del 20% al 13%) la quota di esportazioni verso gli USA. Inoltre, la composizione degli scambi tra i due paesi evidenzia una maggiore fragilità dal lato degli USA, che esportano verso la Cina principalmente prodotti agricoli, più facilmente sostituibili. La soia americana potrà essere rapidamente sostituita da Pechino aumentando le importazioni dal Brasile. Sarà molto più difficile fare lo stesso per gli USA perché importano beni ad alto valore aggiunto, che entrano come componenti in catene del valore complesse. E poi molte delle importazioni dalla Cina non sono beni di consumo, ma beni intermedi da utilizzare per la produzione di manufatti venduti all’interno, che la guerra commerciale rende più difficoltosi e costosi da produrre. Per riorientare le catene del valore e ridurre la dipendenza dalla Cina e da altri paesi a bassi salari occorreranno anni e certamente Trump non ne vedrà gli effetti.
ll "privilegio esorbitante" del dollaro e i vantaggi per gli Stati Uniti. Considerando il problema del deficit nei conti con l’estero statunitensi dobbiamo tener presente il "privilegio esorbitante del dollaro", espressione con la quale il ministro francese Valéry Giscard d'Estaing descriveva i vantaggi unici e sproporzionati che gli Stati Uniti ottengono dal fatto che il dollaro sia la principale valuta di riserva mondiale. Il dollaro è la valuta più utilizzata per le transazioni internazionali, viene usato per difendere le valute nazionali, per ripagare debiti e per gestire le crisi da parte di banche centrali e investitori di tutto il mondo. Molti paesi detengono grandi riserve di dollari e titoli del debito statunitense. Questo privilegio si concretizza nel fatto che:
a) gli Stati Uniti possono finanziare più facilmente il loro debito pubblico e il deficit commerciale (importazioni > esportazioni) perché c'è una costante domanda di dollari da
parte del resto del mondo. In pratica, possono "stampare" dollari in grande quantità con cui pagare beni e servizi importati, senza subire una svalutazione significativa della propria moneta, come accadrebbe a un paese la cui valuta non è una valuta di riserva.
b) gli Stati Uniti hanno costi di finanziamento bassi: c’è una elevata domanda mondiale di titoli di stato americani (i Treasures, denominati in dollari, anche questi vanno a riserva e sono immediatamente convertibili in $) che mantiene bassi i tassi di interesse per il governo
statunitense, permettendogli di indebitarsi a costi contenuti.
c) la presenza militare e le spese per la difesa, inclusa la partecipazione alla NATO, hanno rafforzato nel dopoguerra la posizione degli Stati Uniti come potenza mondiale, contribuendo indirettamente a aumentare la fiducia nel dollaro anche se la relazione tra queste spese e il ruolo del dollaro come valuta di riserva non è immediata.
È importante notare che questo sistema è stato molto stabile per decenni, ma ora vari elementi, Trump incluso, fanno pensare che sia giunto al termine della corsa.
La politica sovranista di Trump ha come conseguenza importante, oltre al ventilato ritiro dalla Nato, l’indebolimento delle istituzioni internazionali, come l'Organizzazione Mondiale per il Commercio e all’ abbandonato accordi globali sul clima, sul nucleare iraniano e sulla sanità e favorisce invece la crescita di altre potenze come la Cina. Quest’ultima infatti ha rafforzato la propria presenza internazionale in seno a queste organizzazioni, specialmente nel settore energetico e sanitario.
La visione "America First" ha portato a un ritorno a un approccio più nazionalista, riducendo il ruolo delle diplomazie tradizionali e delle istituzioni internazionali, favorendo un mondo più frammentato e conflittuale. Tutto ciò ha messo in dubbio la fiducia nella stabilità economica e politica degli Stati Uniti, che è un elemento cruciale per il mantenimento dello status di valuta di riserva del dollaro. Sono sorti dubbi sulla sostenibilità a lungo termine del sistema centrato sul dollaro, sia in relazione all'aumento del debito pubblico statunitense e alle tensioni geopolitiche che potrebbero spingere alcuni paesi a diversificare le proprie riserve. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un indebolimento del dollaro, una fuga di capitali dalla borsa americana, una crescita del tasso di interesse sui titoli statunitensi (ricordiamo le critiche di Trump al presidente della Federal Reserve per tenere alti i tassi di interesse) e una crescente incertezza sui mercati globali.
Economia di guerra
Dal RiArmo europeo alle risorse per la Nato. Il piano di riarmo europeo nasce lo scorso marzo in un contesto di crescente instabilità geopolitica e nell’incertezza sulle future relazioni transatlantiche. Si tratta di una proposta della Commissione denominata "ReArm Europe 2030", ribattezzata poi “Preparati 2030” con un goffo tentativo di farlo digerire all’opinione pubblica, consiste in una strategia dell'Unione Europea volta a rafforzare significativamente le proprie capacità di difesa, riducendo la dipendenza da attori esterni (in particolare gli Stati Uniti) e aumentando la propria autonomia strategica. La proposta deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione Europea e dal Parlamento europeo: la Commissione ha tuttavia scelto di utilizzare una clausola di emergenza (art. 122 del Trattato) e così ha evitato di coinvolgere il Parlamento Europeo.
La Commissione prevede che l’insieme dei paesi europei possa mobilizzare attraverso investimenti nazionali dedicati agli armamenti, sotto la spinta della guerra in Ucraina e delle tensioni con la Russia, 800 miliardi di euro distribuiti su quattro anni (200 miliardi all'anno riferiti all’insieme dei 27 paesi). Questa mobilizzazione avverrebbe in due modi. Il primo, che dovrebbe raggiungere i 650 miliardi, consiste in una azione di persuasione verso i singoli paesi a spendere risorse aggiuntive per la difesa, senza che tale spesa incappi nei vincoli di bilancio europei, rappresentati dai due rapporti deficit/PIL e debito/PIL stabiliti nel Patto di Stabilità e Crescita. I limiti fissati dal Patto di Stabilità restano comunque in vigore nel lungo periodo per cui per i paesi indebitati come l’Italia, l’incentivo consiste nella possibilità di aumentare subito gli investimenti nella difesa sforando i vincoli di bilancio, salvo rientrarvi rapidamente contraendo le spese in altri settori (sanità, istruzione, giustizia etc.). Pur spendendo di più e/o emettendo debito aggiuntivo, la Commissione Europea non considererebbe quell'aumento come un peggioramento del deficit o del rapporto debito/PIL, perché non intende penalizzare i paesi che investono nella difesa nel nuovo contesto geopolitico.
Il secondo modo si dovrebbe concretizzare in un finanziamento di 15 milioni (650+150=800) ai paesi membri che potrebbero attingere a un fondo comune europeo, finanziato tramite emissione di debito congiunto (come avvenuto per il Next Generation EU) per acquistare armi. In questo caso, la spesa rappresenterebbe un intervento diretto comunitario, una compartecipazione al debito comune. La strada del debito comune non ha ottenuto il consenso, e di conseguenza, l'onere finanziario per il riarmo resta tutto a carico dei bilanci nazionali.
Il vertice NATO all'Aja, tenutosi il 24-25 giugno 2025, innova profondamente questo quadro. Il vertice ha stabilito un nuovo obiettivo di spesa per la difesa, molto più ambizioso, proposto e voluto da Trump. Trump ha sostenuto che gli alleati europei non contribuiscono sufficientemente alla propria difesa, esortandoli ad aumentare le spese militari di fronte a un disimpegno statunitense. Si tratta di portare la spesa per la difesa dei paesi membri al 5% del PIL entro il 2035: la richiesta del presidente degli Stati Uniti ha raccolto l’impegno dai paesi UE membri della Nato, tranne la Spagna del coraggioso Pedro Sánchez che non si è piegato alle insistenze di Trump.
L’enormità dell’obiettivo NATO emerge con chiarezza se notiamo che gli stessi Stati Uniti oggi dedicano meno del 3,5% delle loro spese alla difesa.
L’ obiettivo NATO del 5% è suddiviso in un 3,5% per le esigenze di difesa “specifiche” e un 1,5% per investimenti correlati alla difesa e alla sicurezza, come infrastrutture e industria. Queste ultime voci non sono ben definite, possono includere le spese più disparate, e la loro incerta definizione ha lo scopo di rendere l'obiettivo "politicamente più facile da digerire" per molti paesi.
L'autonomia dell’Europa o la rottamazione dello stato sociale. Fermiamoci dunque all’obiettivo del 3,5%. L’Italia al pari di altri paesi europei, storicamente caratterizzati da robusti sistemi di welfare sociale, si dibatte da anni tra l’elevato debito pubblico e bassi tassi di crescita economica. Questa situazione rende estremamente difficile aumentare la spesa per la difesa (a meno di non ipotizzare una irrealistica crescita del PIL o l'imposizione di nuove tasse) e ciò rende necessari dolorosi tagli in altre categorie di bilancio. Il nostro paese, dovrebbe quasi triplicare la sua attuale spesa diretta per la difesa che oggi si aggira sui 30-35 miliardi di euro, richiedendo 45-50 miliardi in più per passare dall’1,6 per cento attuale al 3,5 per cento del PIL, il che renderebbe necessari tagli sostanziali ad altre voci del bilancio pubblico.
Ad esempio la spesa sanitaria (pubblica) è stimata sui 130 miliardi, toglierne 20 per girarli alla difesa significa aprire il campo a un aumento della spesa sanitaria privata che da 45 passerebbe a 65 miliardi mentre la spesa sanitaria pubblica si ridurrebbe a 110 miliardi, scendendo dallo 0,65 al 0,55 del PIL: oggi la media UE è 0,66%. Si dovrebbero poi togliere altri 20 miliardi ad altre voci, ad esempio dai 79 miliardi spesi per l’istruzione, che oggi è il 3,9%, contro una media UE del 4,7, e passerebbe a un miserrimo 2,9%.
La scadenza per questi impegni è stata estesa al 2035 e una revisione è programmata per il 2029, suggerendo un implicito riconoscimento di queste difficoltà; la ricalibrazione verrebbe affrontata molto gradualmente, ma ciò non rende meno amara la pillola.
L’accordo siglato alla Nato appare l’occasione che le élite europee conservatrici hanno colto senza farselo ripetere due volte per cercare di rottamare definitivamente lo stato sociale: se una parte significativa delle risorse statali viene riallocata dalla spesa sociale o dagli investimenti in infrastrutture civili alla spesa militare, i termini di questo contratto stanno cambiando in modo surrettizio. Questo mutamento non avviene infatti attraverso un dibattito pubblico aperto e una scelta democratica esplicita, ma piuttosto come una conseguenza "implicita" di decisioni prese altrove, ad esempio, in sede NATO o come una necessità imposta da circostanze esterne, ad esempio, minacce geopolitiche, a volte enfatizzate ad arte.
I governi si presentano come "costretti" ad aumentare la spesa militare per impegni internazionali, e questo porta a tagli impliciti alla spesa interna senza che vi sia un esplicito consenso popolare. La spesa pubblica viene posta al servizio dei grandi gruppi industriali-militari e le sue funzioni vengono gradualmente privatizzate, diventando inaccessibili per chi non se lo può permettere.
Il riferimento al “modello Trump” è immediato in quanto la sua politica "America First" ha implicato una forte enfasi sulla spesa per la difesa e una riduzione di altri ambiti di spesa. Tagli a Medicaid (l'assistenza sanitaria per i cittadini a basso reddito e le persone con disabilità) e allo SNAP (Supplemental Nutritional Assistance Program), il programma di sussidi alimentari, tagli fiscali sui redditi alti, tagli ai fondi per l’istruzione (stanziamenti già approvati dal Congresso), smantellamento del Dipartimento dell’istruzione, uso dei fondi come leva politica. Si tratta di una ridefinizione indiretta delle priorità nazionali che ha profonde implicazioni sulla vita dei cittadini e sui valori su cui si fonda la società in cui viviamo.
Il riarmo e l’indebolimento della diplomazia. La critica principale al piano di riarmo è quella che il Piano contribuirà a un'escalation della corsa agli armamenti globale e costituirà una minaccia alla pace, trasformando l'UE da un progetto politico orientato alla pace a un blocco militare.
Oggi l'Europa non manca di armi, ma di capacità diplomatica. Una forte componente diplomatica dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi sforzo di riarmo. Senza di essa, si rischia di:
a) Minare l'unità europea: un approccio frammentato alla difesa, privo di una visione diplomatica unificante, porterà inevitabilmente al sorgere di interessi nazionali divergenti da parte di paesi ben armati, che prevalgono sugli obiettivi collettivi di sicurezza europei. La vera forza non risiede solo nella potenza militare, ma in un fronte unito che sfrutta sia il potere delle armi che quello della diplomazia.
b) Esacerbare le tensioni concentrandosi esclusivamente sul potenziamento militare senza parallele aperture diplomatiche sarà essere percepito come un'escalation dai potenziali avversari, portando a una contrapposizione sul piano militare. Investire massicciamente in equipaggiamenti militari senza perseguire contemporaneamente vie di dialogo e negoziazione significa sprecare le possibilità di affrontare le cause profonde del conflitto, costruire la fiducia e trovare soluzioni pacifiche.
L’Unione europea oltre a investire in una propria difesa indipendente da USA e NATO, dovrebbe mettere in pratica una diplomazia attiva unitaria. Non si può affrontare un mondo interconnesso con risposte nazionali. Occorre un cambio di paradigma che ponga al centro la cooperazione, la diplomazia, il multilateralismo e la sostenibilità. L’alternativa è un mondo sempre più frammentato, diseguale e sull’orlo della guerra.
Aumentare significativamente la spesa per militare non ha senso dal punto di vista dell’efficacia dei sistemi di difesa. La spesa militare aggregata dell'Unione Europea ha raggiunto circa 1,95% del PIL nel 2024, il problema è la sua frammentazione tra i singoli Stati.
La mancanza di coordinamento e di una strategia comune porta alla duplicazione delle risorse. Molti paesi sviluppano e acquistano sistemi d'arma simili in modo indipendente, senza una sinergia che potrebbe portare a una maggiore interoperabilità tra le forze armate europee. Risulta di efficacia ridotta perché riduce la capacità di dispiegare una forza militare europea coerente e unita.
La domanda di armamenti come generatrice di crescita economica. L’analisi storica ci insegna che, soprattutto in certi periodi (ad esempio, durante le guerre mondiali o la Guerra Fredda), un aumento significativo della spesa militare poteva generare un impulso economico attraverso la domanda di armamenti. La spesa per la difesa era considerata un traino per l'innovazione, poiché finanziava progetti ad alto rischio e ad alto potenziale che, una volta maturi, trovavano applicazioni nel settore civile. Ne sono esempio , ARPANET, il precursore di Internet, la Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata nella difesa (DARPA) con l'obiettivo esplicito di stimolare la ricerca scientifica e tecnologica al fine di superare l'avanzamento dell'URSS, che ha assunto compiti esplicitamente militari, il GPS e altre innovazioni dove lo stato svolse il ruolo di traino.
Con la fine della Guerra Fredda e l'avvento dell'era digitale, il rapporto tra spesa militare e innovazione ha subito una profonda trasformazione. Il settore privato è trainato da cicli di innovazione sempre più rapidi e da un volume di investimenti senza precedenti ed è diventato il principale motore del progresso tecnologico. in cui le forze armate adattano e integrano tecnologie sviluppate per il mercato civile. Gli esempi più evidenti sono l'intelligenza artificiale (IA), la tecnologia dei droni e la tecnologia satellitare. In questi casi il motore è stato il settore privato alla ricerca di profitto nel campo delle comunicazioni globali e delle comunicazioni sicure, del controllo a distanza, della sorveglianza, delle previsioni meteo, della navigazione civile.
Questo ha portato a un'inversione del flusso di innovazione che ora muove dal settore civile al militare.
Una crescita comunque limitata. Sebbene l'industria della difesa crei posti di lavoro, la sua incidenza sul PIL complessivo di un paese occidentale è spesso limitata. In Europa, ad esempio, il settore militare realizza appena lo 0,7% del PIL e ha effetti limitati sull'occupazione.
L’idea che il gigantesco piano di riarmo europeo rappresenti un’opportunità di crescita occupazionale e di riconversione di un settore in crisi come l’automotive è sfatato dalla storia dell’industria. Negli ultimi 10 anni ad aumentare sono stati ricavi e titoli in Borsa, i risultati sull’occupazione sono stati modesti.
L’intera catena dei sub-fornitori (fino a quelli di terzo livello) stimata da AerospaceSecurityDefense in circa 2 mila imprese, il fatturato complessivo (diretto + indiretto) dell’industria militare si attesta intorno all’1,1% del PIL. Una quota notevolmente inferiore, ad esempio, al settore auto (7% del PIL) o quello dei “macchinari e automazione industriale” (4,9% del PIL).
Il divario in termini di posti di lavoro è ancora maggiore: 6 milioni e 600 mila nei comparti manifatturieri dell’auto e 3 milioni e 700 mila nel settore dei macchinari e automazione industriale, contro 1 milione e 30 mila tra diretti e indiretti dell’industria militare (compresa la supply chain) nel 2021.
Abbiano nei 43 anni considerati una imponente crescita, del fatturato complessivo del settore aeronautico europeo (oltre il 380% in più). Viceversa, nello stesso periodo il numero di occupati registra un aumento di solo il 10%: dai 547 mila addetti nel 1980 ai 603 mila occupati nel 2023, dopo il sensibile declino registrato tra il 1991 e il 1996 in conseguenza della fine della Guerra Fredda. Il disaccoppiamento tra andamento del fatturato e andamento del numero di occupati è alquanto evidente ed è dovuto a due elementi:
1. Crescono gli occupati nell’aeronautica civile e cadono in quella militare;
2. buona parte delle spese di difesa si tramutano in importazioni di armi.
Il caso dell’Italia. I dati Istat sulla produzione industriale mostrano 2 anni consecutivi di calo in Italia. Il taglio al Fondo automotive per dirottare risorse alla Difesa (es. Leonardo che sposta investimenti dal civile al militare).
I dati che parlano con grande chiarezze sono tuttavia quelli relativi alle importazioni/esportazioni di armi.
Nel 2016 2017 registriamo un picco delle importazioni di armi dovuto agli Usa e a Israele, Francia e Germania (Israele ha comperato elicotteri e in cambio abbiamo comparato missili e simulatori). Dagli Usa F35: l’acquisto di F35 è iniziato dal governo Berlusconi nel 2008-11, proseguito da tutti i governi Monti, di centro destra e sinistra (Conte incluso). L’alternativa era l’Eurofighter Typhoon, caccia multiuso un po' più tradizionale (Italia 110 contro previsti 90 F35; Regno Unito 160 contro 30; Germania 150 contro circa 50; Francia ha solo Dassault Rafale).

Siamo incapaci o non vogliamo lavorare in campo aeronautico? C’è il successo di Airbus, il più importante programma industriale e tecnologico realizzato a livello europeo con la cooperazione tra Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna: Airbus ha superato di poco Boeing. Un programma al quale l’Italia – con Finmeccanica-Aeritalia, ora diventata Leonardo – ha scelto di non partecipare: la rinuncia è costata la marginalità dell’industria italiana nella ideazione, sviluppo e produzione di aerei civili. Ma è costata molto anche in termini di mancata creazione di posti di lavoro. Infatti, mentre in Francia, Germania e Spagna, il calo degli occupati nel militare (meno 43%) è stato compensato da una crescita nel civile (più 96%), In Italia, negli stessi anni, si è perso oltre la metà dei posti di lavoro nel settore aeronautico militare, senza aver registrato alcuna crescita nel campo dell’aeronautica civile (tranne un 10% in più nel comparto elicotteri). I principali paesi membri del consorzio Airbus impiegano complessivamente circa 80.000-90.000 persone, con Airbus come azienda globale che ne impiega circa 130.000.
Questi numeri mostrano come la partecipazione al consorzio Airbus sia fondamentale non solo per lo sviluppo tecnologico, ma anche per l'occupazione e l'economia dei paesi coinvolti.
L’Italia sembra continuare sulla via “americana” infatti ha scelto di non partecipare al progetto FCAS (Future Combat Air System), un sistema di combattimento aereo di nuova generazione sviluppato da Francia, Germania e Spagna, con l’obiettivo di creare un caccia di quinta generazione e sistemi di supporto avanzati. Prototipi si dovrebbero vedere al 2027-30.
Anche nel caso che gli 800 miliardi previsti dal piano ReArm Europe/Readiness 2030 siano pienamente utilizzati, l’analisi empirica sui trend occupazionali verificati nell’industria americana e in quella europea della difesa nel primo quarto del Secolo XXI (con fasi alternate di contrazione e di crescita contenuta), è difficile immaginare un aumento dell’occupazione nel settore superiore al 25-30%. Tenendo conto non solo degli occupati diretti in ambito militare, ma anche dell’intera catena dei sub-fornitori (fino a quelli di terzo livello) stimata da ASD in circa 2 mila imprese, stiamo parlando in valore assoluto di un incremento intorno alle 250-300 mila unità sull’intera Europa. Un numero irrilevante rispetto alla dimensione della crisi delle automotive che coinvolge milioni di lavoratrici e lavoratori. Il riferimento è alla decisione del governo di spostare 4,9 miliardi di euro già stanziati per il sostegno alla “transizione ecologica e sociale nel settore auto” verso l’aumento delle spese militari.