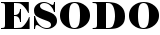di Giannino Piana
Nelle scuole superiori si stanno diffondendo i progetti “Carriera Alias” dedicato a studenti transgender. Quale la tua valutazione? A quali condizioni sono progetti positivi per l’educazione al rispetto delle diversità e per la presa di coscienza matura della propria sessualità?
Devo confessare le mie perplessità per l’iniziativa, messa in atto dalla preside del liceo “Marco Polo” di Venezia, di fornire la facoltà per gli studenti transgender di cambiare il nome anagrafico in quello del genere in cui si riconoscono. Naturalmente non sono d’accordo con gli interventi esagitati degli esponenti di Fratelli d’Italia, che parlano di “falsità ideologica” e di “ingerenza inaccettabile”, anche perché – questo deve essere sottolineato – il progetto è stato concordato dalla preside con il Consiglio di Istituto, il collegio docenti e i genitori.
Sono però anche in disaccordo con l’Anpi veneziana che parla di ritorno allo Stato etico, di violazione dei principi costituzionali (art. 3 e 34), di pregiudizi e di discriminazione, di offensiva culturale con una impronta transfobica. Ho seguito all’inizio con una certa simpatia la nascita degli studi di gender (così venivano allora definiti), perché affrontavano una questione reale, quella dell’importanza del costrutto socioculturale sulla formazione dell’identità di genere della persona, purtroppo per molto tempo ricondotta esclusivamente (e qui vi è anche una grossa responsabilità della Chiesa cattolica) al dato biologico, dando vita a un determinismo materialista, che contraddice l’esperienza che tutti facciamo delle diversità degli atteggiamenti, dei modi di sentire e di agire, di soggetti che hanno in partenza un patrimonio biologico (il Dna) identico. Ricordo a tale proposito di essermi trovato d’accordo con la posizione assunta dai vescovi appartenenti al gruppo di lingua tedesca che, in occasione del primo Sinodo sulla famiglia, avevano avanzato la proposta, sulla scorta degli studi sul gender, di ripensare l’identità di genere nell’intreccio tra bios e costrutto socioculturale. Purtroppo si è passati però successivamente a parlare di “teoria del gender”, assegnando ad essa un'eccessiva e indimostrata credibilità scientifica (fino a correre talvolta il rischio della caduta nell’ideologia), con la rinuncia, o almeno il forte ridimensionamento, del dato biologico cui va riconosciuta una funzione importante (anche se certo non esclusiva) nella definizione dell’identità di genere. Ne sono scaturite (e sono sempre più diffuse) teorie pedagogiche che ritengo personalmente inaccettabili, perché rischiano di creare uno stato accentuato di incertezza e di insicurezza emotiva in soggetti fragili – i bambini e gli adolescenti – che, vivendo in una situazione di precarietà e di instabilità, hanno bisogno di modelli precisi di riferimento.
Certamente tali progetti possono creare atteggiamenti di paura e di sospetto per chi è stato educato a modelli statici in cui erano, o apparivano, chiari gli orientamenti sessuali, i ruoli e le identità maschili e femminili. Anche la morale e l’educazione cattolica non è preparata ai cambiamenti sociali e culturali. Come realizzare un dialogo fecondo per la condivisione di soluzioni positive?
La paura e il sospetto non sono del tutto senza fondamento. Me lo confermava di recente un’amica psicologa di formazione laica, la quale si diceva allarmata per il numero di adolescenti, che venivano a lei inviati dai loro genitori per problemi di identità di genere dopo la diffusione da parte dei vari media (spesso con la descrizione di effetti stravaganti) della teoria del gender. La delicatezza della questione impone prudenza, specialmente nella elaborazione di progetti educativi, che per il perseguimento del giusto obiettivo di favorire il rispetto delle diversità e la presa di coscienza matura della propria sessualità, corrono il pericolo di alimentare fluidità e indifferenziazione radicali. Non si può certo negare che la morale e l’educazione cattolica siano stati (e in parte lo siano tuttora) in arretrato rispetto ai cambiamenti sociali e culturali, e che questo esiga la messa in atto di un dialogo aperto e sereno anche con i sostenitori della teoria del gender e soprattutto del suo inserimento nel curriculum scolastico: la ricerca della condivisione di soluzioni positive è un fine che va in ogni modo perseguito, senza rinunciare per questo all’assunzione di un atteggiamento critico, ma sforzandosi di conoscere le ragioni dell’altro e di mettere in discussione la propria posizione (specialmente, come non è infrequente, rigidamente dogmatica) per accogliere elementi di verità presenti in tali ragioni.
Come e in che limiti lo Stato può/deve regolamentare i comportamenti relativi alla sfera individuale e sessuale, sempre più diversificati e fluidi? In Italia c’è il rischio che si riproponga uno “Stato etico”, in base a presunti “valori etici nazionali” strumentalizzando la costruzione di una identità cristiana della nazione?
La risposta a questi interrogativi non è facile. Si tratta di questioni complesse, che esigono un rigoroso discernimento. L’intervento dello Stato nella regolamentazione dei comportamenti relativi alla sfera individuale e sessuale è senz’altro legittimo. Il problema è semmai quello di rintracciare un giusto equilibrio, sempre in divenire, tra il rispetto delle scelte personali e la normatività giuridica, la quale non può prescindere dall’attenzione alla sempre maggiore fluidità e diversificazione delle situazioni soggettive. In questo necessario sforzo non va tuttavia dimenticato che la formulazione delle leggi non può avvenire affidandosi a criteri puramente procedurali, ma deve affondare le radici in un substrato etico, in un ethos condiviso dalla maggioranza. So quanto sia difficile giungere oggi a questa condivisione, in presenza di quella che Max Weber definiva come “politeismo dei valori” (meglio sarebbe forse dire dei “sistemi valoriali”) e del venir meno di quelle che venivano riconosciute in passato come “evidenze” etiche. Ma non si può e non si deve rinunciare per questo alla messa in atto di un processo di confronto allargato – l’"etica della comunicazione" di Habermas e Apel ci forniscono al riguardo preziose indicazioni metodologiche – che conduca alla definizione di un minimo comune denominatore al quale fare riferimento. Ne va della stessa identità del diritto la cui natura prevede il riferimento ad alcuni presupposti irrinunciabili. Tutto questo senza dimenticare l’identità del diritto che esige, accanto al riferimento valoriale, come criterio imprescindibile il criterio dell’efficacia: un diritto che non si misurasse con questo criterio finirebbe per essere un cattivo diritto, che si limita a proclamare in astratto valori anche importanti ma senza la dovuta mediazione in rapporto alla concretezza delle situazioni, emettendo enunciati di principio che risultano di fatto impraticabili. Quello che mi preme sottolineare è l’esigenza di non incorrere in una forma di relativismo assoluto, che non consentirebbe più di distinguere il bene dal male, sovrapponendoli e confondendoli, facendoli diventare, in una parola, del tutto interscambiabili. Il che avrebbe (e non potrebbe non avere) ricadute pesantemente dannose sull’intero tessuto sociale. Quanto al ventilato possibile ritorno allo “Stato etico” non mi pare sussistano (almeno per ora) i presupposti, grazie soprattutto alla protezione della nostra Carta costituzionale fondata sui principi della libertà e della democrazia. Il che non significa che il pericolo non sussista, se si pensa al governo di centrodestra, meglio chiaramente di destra, presente oggi nel nostro Paese a guida Fratelli d’Italia, un partito che ha spesso avanzato in passato tale ipotesi e che anche nei mesi trascorsi non ha mancato (e non manca) di dare segnali allarmanti della tentazione di muoversi in tale direzione. Speriamo in una forte reazione (fino ad ora non registrata) del popolo italiano, già incorso in un passato non molto remoto in tale grave deriva.