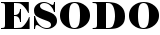di Maurizio Ambrosini
Erano state 2.406 le morti accertate nel Mediterraneo, e 2.062 nel 2021, senza che un’opinione pubblica distratta fosse disposta a versare qualche lacrima o, più ancora, a incrinare la leggenda di un paese assediato da torme di migranti. Ma la tragedia di Cutro alla fine di febbraio, a pochi metri dalle coste della Calabria jonica, ha scosso la coltre dell’indifferenza, obbligando tutti a guardare negli occhi la sorte di chi attraversa il mare con mogli e figli a rischio della vita. E obbligando a interrogarsi sui dispositivi di sorveglianza del mare e di salvataggio di chi è in pericolo.
Sono quindi serie le questioni che s’intrecciano intorno al naufragio di Cutro e delle risposte politiche che il governo ha fornito, prima con la campagna anti-ONG, poi con la tardiva e teatrale convocazione del Consiglio dei Ministri nella cittadina calabrese il 9 marzo scorso.
Anzitutto, i numeri degli sbarchi smentiscono chiaramente il teorema secondo cui i profughi arriverebbero a causa della presenza delle navi umanitarie pronte a salvarle (i “taxi del mare”, o i “vice-scafisti”, secondo la crudele retorica sovranista). Le navi delle ONG nel 2022 hanno soccorso e sbarcato in Italia meno del 12% del totale delle persone arrivate via mare. Come si è scoperto nel caso di Cutro, gli altri arrivano o con i propri mezzi, oppure vengono tratti in salvo da Marina Militare e Guardia Costiera, a volte anche da comuni navi mercantili. Nel 2023, a decreto anti-ONG in vigore, a fine febbraio erano sbarcate in Italia 14.104 persone, contro 5.345 nel 2022 e 4.304 nel 2021. Dunque con meno navi umanitarie a presidiare il mare è arrivato il triplo dei profughi. Le ragioni delle partenze sono più complesse degli slogan. Basti pensare alla provenienza delle vittime di Cutro, in larga prevalenza afghane.
La seconda questione riguarda l’organizzazione dei soccorsi. Il governo non ha fornito spiegazioni convincenti, dicendo prima che non era stato avvertito, poi che il mare grosso aveva impedito di far uscire le navi militari, quindi, una volta resa nota la segnalazione di Frontex, che l’informazione non parlava di una barca in pericolo. E’ emerso un conflitto di competenze tra ministeri e corpi militari (Guardia di Finanza e Guardia Costiera), nonché un implicito discredito delle competenze tecnico-professionali degli addetti alla sorveglianza delle coste: serviva una segnalazione più circostanziata di Frontex per rendersi conto che la barca rischiava di affondare nel mare in tempesta? Sconcerta in ogni caso, per un governo che fa della difesa dei confini un principio inscalfibile, l’idea che un natante non identificato possa approdare indisturbato sulle nostre coste, senza essere intercettato e controllato.
Il Consiglio dei ministri, convocato a Cutro con il chiaro intento di fornire una risposta al naufragio, ha abbozzato una sorta di nuova politica sugli arrivi di profughi dal mare: un fenomeno, va ricordato, che sotto i precedenti governi aveva provocato ripetute richieste di dimissioni della ministra degli interni Lamorgese. Ma di fatto il governo ha confermato che l’approccio all’immigrazione è una cifra identitaria della coalizione uscita vittoriosa dalle elezioni dell’autunno scorso e un terreno su cui rafforzare i legami con il proprio elettorato, soprattutto quello più sensibile alle istanze sovraniste in materia di confini.
Una parziale novità, già peraltro anticipata dal decreto-flussi del 2023, riguarda la maggiore apertura all’immigrazione per lavoro, oggetto della prima parte del decreto governativo uscito dal CdM di Cutro. E’ soprattutto una risposta alle istanze dei datori di lavoro, non un’alternativa al diritto d’asilo. A voler essere ottimisti, i nuovi ingressi legali potrebbero raccogliere qualche interesse da parte di chi oggi arriva da paesi come Tunisia ed Egitto: se va bene, una parte dei richiedenti asilo. In realtà non offre soluzioni a chi fugge da paesi in guerra o dominati da regimi oppressivi. Quelli cioè da cui provenivano le vittime di Cutro, quasi tutti afghani. Il decreto-flussi non contemplava ingressi da questi paesi, ed è improbabile che le nuove norme li prevedano: gli ingressi per lavoro si concedono a paesi amici, in questo caso secondo il decreto anche disposti a collaborare a campagne mediatiche di dissuasione delle partenze, della cui efficacia è lecito dubitare. I profughi in cerca di asilo invece arrivano da paesi ostili o sconvolti da conflitti e repressioni.
Restano però da verificare due condizioni: la prima è l’effettivo snellimento delle procedure, posto che alla costante priorità delle istanze securitarie si è aggiunta la necessità di verificare la reperibilità di candidati italiani per i posti di lavoro vacanti. La seconda è la disponibilità dei datori di lavoro a negoziare le nuove assunzioni di lavoratori in modo diverso da come hanno fatto abitualmente: ossia assumendo dei perfetti sconosciuti, appena arrivati dall’estero, anziché persone conosciute che in realtà già lavorano presso di loro. A questo infatti sono fin qui serviti i decreti flussi, a parte forse una parte delle assunzioni stagionali, quando sono riuscite a passare in tempo utile i vari passaggi burocratici previsti. In Francia, Spagna e in modo un po’ diverso in Germania, i governi stanno cercando di rispondere alle carenze di manodopera regolarizzando su base individuale gli immigrati irregolari già inseriti nel mercato del lavoro, senza l’appesantimento di verifiche e autorizzazioni all’ingresso.
Sugli ingressi per ragioni umanitarie il governo invece si è mosso in senso contrario. Nelle norme approvate non si trova traccia dei corridoi umanitari, di cui sia il ministro Piantedosi sia la premier Meloni avevano parlato subito dopo la tragedia. Anzi, la linea è quella di una maggiore chiusura dei confini nei confronti di chi non rientra nella categoria dei lavoratori autorizzati, donne e bambini compresi. Dopo il decreto anti-ONG di gennaio, le nuove norme prevedono diverse misure di restrizione e allontanamento. La prima è il rafforzamento dei CPR, ossia dei centri detentivi per gli immigrati che si vorrebbero espellere, con ciò certificandone l’inadeguatezza (l’Italia espelle soltanto circa 5-6.000 immigrati all’anno, anche ai tempi di Salvini agli Interni). La seconda è l’inasprimento delle pene per i cosiddetti scafisti, su cui il governo ha cercato di canalizzare le accuse del naufragio. Si continua a pensare che le barche siano guidate da potenti boss del traffico di persone, ma in realtà si tratta dell’ultimo anello della catena. In genere giovanissimi, a volte minorenni, come uno degli arrestati di Cutro, a volte connazionali delle persone trasportate: ossia malcapitati che accettano di guidare le barche in cambio del costo del trasporto. I boss non si mettono in mare, rischiando la vita o l’arresto. Dal punto di vista di chi fugge, accompagnato magari da moglie e figli, in mancanza di mezzi di trasporto legale i trasportatori illegali sono come minimo un male necessario. Se il viaggio va a buon fine, assurgono al rango di benefattori. Varie ricerche assicurano che i più noti ed esperti sono persone riconosciute, apprezzate e riverite nelle proprie comunità etniche.
All’ultimo momento, è stato inserito un po’ a sorpresa un altro intervento che rafforza la chiusura sull’asilo: la restrizione della “protezione speciale”, ossia di quella formula flessibile che consentiva di regolarizzare chi, pur non essendo accettato come rifugiato, aveva imparato l’italiano e trovato un lavoro, oppure aveva legami familiari con persone che vivono in Italia. Come è avvenuto con i decreti-sicurezza di Salvini, in sostanza si butteranno per strada persone che stavano integrandosi, dando un contributo alla nostra economia, oppure si erano ricongiunte ai familiari. La lentezza delle procedure, il sistema delle garanzie (come l’inalienabile diritto di appello), le difficoltà dei rimpatri, fanno sì che i richiedenti asilo rimangano sul territorio, quale che sia l’esito della loro domanda: al più, se ne vanno verso Nord attraversando le Alpi. Con meno possibilità di ottenere un esito favorevole alla domanda di asilo, si aumenterà il numero degli sbandati e il degrado degli spazi pubblici nelle città. Grave e poco comprensibile inoltre la penalizzazione dei legami familiari. L’argomento secondo cui la protezione speciale vige soltanto in pochi paesi dell’UE trascura le regolarizzazioni caso per caso a cui ricorrono altri governi: non è la protezione speciale perché è più ampia, non si applica solo ai richiedenti asilo ma anche ad altri immigrati in condizione irregolare. Magistratura democratica ha pubblicato un elenco di 20 paesi UE su 28 in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale. In sostanza, il governo Meloni asseconda la domanda di braccia, ma vuole chiudere le porte alle persone.
L’approccio del governo al tema merita un approfondimento. Le migrazioni sono fenomeni complessi e hanno diverse cause, ma il governo Meloni sembra soggetto a una coazione a ripetere che lo spinge in tre direzioni: allarmare, semplificare, trovare dei responsabili da incolpare. In primo luogo, l’allarmismo. E’ vero, come abbiamo visto sono aumentati gli arrivi dal mare in questo primo scorcio dell’anno. Parlare però di aumento esponenziale, oltre a essere un insulto alla matematica, dipende come sempre dal fatto che quei profughi in arrivo dal Sud del mondo non piacciono al governo e a tanti italiani. Basti pensare che nella primavera scorsa abbiamo accolto 170.000 profughi ucraini (e la Germania un milione) senza lanciare grida di allarme, ma con encomiabile solidarietà. Mentre si vorrebbero far entrare nuovi lavoratori dall’estero, non si riesce a immaginare che quelli che arrivano fuggendo, se hanno diritto all’asilo, opportunamente accolti e formati potranno contribuire a risolvere la carenza di manodopera. Sempre l’allarmismo guida la diffusione di notizie riguardanti una cifra di 685.000 persone in arrivo dalla Libia: l’ennesima di una serie, perché lanci di questo genere sono avvenuti a più riprese nel corso degli anni. 685.000 è una stima (friabile, non si sa neppure come sia costruita) dei migranti presenti in Libia, ma è ancora più problematico prevedere quanti vogliano partire verso l’Europa e come possano trovare i mezzi per farlo.
Qui scatta la semplificazione: i profughi arrivano perché qualcuno li spinge a partire, perché dei mafiosi decidono chi può venire da noi, come ha detto la premier Meloni. Con il corollario pseudo-solidale di sostenere che “chi arriva si trova a fare la manovalanza della criminalità organizzata o diventa vittima della prostituzione”. Meloni ha anche parlato di “schiavitù del terzo millennio”: ma gli schiavisti tenevano soggiogate a vita le persone che cadevano nelle loro mani, mentre ora i trafficanti vendono, a caro prezzo e ad alto rischio, un servizio di trasporto che le persone in fuga non possono acquistare sul mercato legale. Vari altri fatti difficilmente contestabili, che la maggioranza delle vittime di Cutro provenisse dall’Afghanistan, che l’Africa sia sconvolta da decine di conflitti a vari gradi d’intensità, che molti rifugiati giunti negli scorsi anni si stiano inserendo nel lavoro regolare, non entrano nell’analisi. Che le migrazioni e le stesse partenze dei profughi abbiano cause svariate e complesse, non trova spazio. Quanto alla negazione del “diritto a migrare”, la premier con questo linguaggio annuncia in realtà il diniego del diritto di asilo, in quanto strettamente legato alla possibilità di mettere piede in un paese sicuro.
Ecco allora i colpevoli: dopo le ONG e gli scafisti, i mercenari della brigata Wagner. Difficilmente difendibili da ogni punto di vista, ma le nazionalità dei profughi fin qui sbarcati non coincidono con il teatro delle operazioni della famigerata formazione para-militare: i profughi arrivano da Costa d’Avorio (3.002 al 15 marzo), Guinea (2.806), Pakistan (1.541), Bangladesh (1.506), Tunisia (1421). I mercenari russi operano invece in Mali, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana.
Nemmeno la presenza dei mercenari russi in Libia spiega molto, perché più della metà dei 20.000 sbarcati provengono dalla Tunisia, e sono aumentati pure gli arrivi dalla Turchia, come ci ha insegnato la tragedia di Cutro. Anche in Libia, Wagner è installata in Cirenaica a sostegno del generale Haftar, non controlla altri luoghi d’imbarco. In realtà dietro alle partenze ci sono spinte diverse e intrecciate, come la campagna xenofoba del presidente tunisino Saied, la profonda crisi economica del paese, il deterioramento dell’unica democrazia sopravvissuta al riflusso delle primavere arabe. Quanto all’Africa sub-sahariana, i conflitti, l’espansione jihadista, le repressioni e le dittature sono più la regola che l’eccezione: sono problemi più antichi e profondi dell’eventuale e indimostrata pressione russa. Il Pakistan a sua volta è attraversato da una profonda crisi politica ed economica.
L’individuazione dei russi come responsabili ha un obiettivo politico: coinvolgere l’Europa e persino la Nato in un’operazione difensiva che bolli i profughi come “arma ibrida” e li respinga con tutti mezzi, ricorrendo anche alla Marina militare, del cui intervento si torna a parlare. Se siamo in guerra, e i profughi possono essere definiti un’arma di guerra, allora tutto o quasi diventa lecito per scongiurare la minaccia. A questo punta il governo.
Ci possiamo domandare, per concludere, come rispondere diversamente alla sfida degli arrivi dal mare di persone in cerca di asilo.
La prima risposta sarebbe una nuova operazione Mare Nostrum, con il mandato di intercettare i barconi il prima possibile, ben oltre le nostre acque territoriali, fin sotto le coste libiche o turche se necessario. Ma allo stesso tempo si possono mettere in campo delle alternative ai viaggi della speranza. Si potrebbe reintrodurre l’istituto dell’ingresso assistito da uno sponsor, frettolosamente abolito per ragioni ideologiche. Magari prevedendo un doppio sponsor: oltre ai parenti che si fanno garanti, un ente locale o un soggetto della società civile che assuma l’incarico di accompagnare i nuovi arrivati nell’apprendimento della lingua e nel processo d’integrazione.
Quanto ai rifugiati veri e propri, la soluzione dei corridoi umanitari ha già mostrato risultati promettenti e replicabili, coinvolgendo comunità locali, famiglie-tutor e volontari in forme di accoglienza diffusa. Un raro caso fra l’altro, in questo campo, di idea italiana esportata anche all’estero, in Francia, Belgio, Germania. Vanno nella stessa direzione le forme di sponsorizzazione privata da tempo attuate in Canada. Più in generale, la formula dei reinsediamenti in un paese disponibile di chi è stato in un primo tempo precariamente accolto in un paese con poche risorse rappresenta un’alternativa ai viaggi auto-organizzati. Il problema è che i reinsediamenti coinvolgono in media 100.000 persone all’anno a livello mondo, mentre le richieste sono dieci volte maggiori.
Altra e più controversa possibilità è l’esame delle richieste d’asilo prima dell’ingresso nell’UE, così come fanno gli Stati Uniti con il Messico. I problemi non mancano: lunghi tempi di attesa, precarietà dell’accoglienza, incertezza sulla sorte dei respinti e su chi dovrà farsene carico, se per esempio si ammalano. Ma è meglio discutere di soluzioni concrete, con le loro zone d’ombra, che limitarsi a biasimare le partenze, assegnando ai paesi di transito il ruolo di gendarmi delle nostre frontiere. Con i costi in termini di vite umane perdute che periodicamente siamo costretti a piangere.