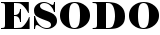di Giannino Piana
La politica non si fonda su se stessa. Ha bisogno di radici antropologiche ed etiche che la supportino e ne determinino lo sviluppo. Quale concezione dell’uomo è stata a lungo alla base del progetto politico occidentale?
Il pensiero occidentale ha fondato, fin dalle origini, la politica su una visione della natura dell’uomo come “essere sociale”, cioè come essere essenzialmente aperto alla società in cui trova la propria realizzazione. Aristotele, che è considerato il padre fondatore della scienza politica, definisce l’uomo “animale politico” (zoon politikon) e concepisce la felicità, che è l’obiettivo della vita morale, come felicità pubblica, che si può attingere solo nel rapporto con gli altri nell’ambito della polis.
A determinare gli sviluppi dell’azione politica è dunque la legge naturale inscritta nel cuore dell’uomo da cui traggono origine le virtù civiche, prima fra tutte la giustizia. Questa visione si prolunga lungo il corso della storia non solo nel mondo greco, ma anche in quello cristiano fino all’epoca medioevale con diverse valenze ma con la sostanziale convergenza attorno al concetto di “natura umana” quale “natura sociale”. Tommaso d’Aquino riprende in proposito la concezione aristotelica, conferendole un fondamento ontologico, e mettendo l’accento sulla “socialità” come realtà costitutiva dell’essere umano. La definizione dell’uomo “animale sociale” ha le sue radici nelle profondità della natura umana, dunque nel nucleo immutabile della legge naturale. Di qui discende per Tommaso la centralità della “giustizia sociale”, la giustizia per eccellenza, da cui derivano le altre forme di giustizia, in particolare quella commutativa e quella distributiva.
Questa visione viene meno con l’avvento della modernità. Quali sono le ragioni di questa svolta?
A determinare il venir meno della fondazione della politica sulla “legge naturale” hanno concorso nella modernità, un insieme complesso di fattori tra loro interagenti. Il primo (e più importante anche se spesso dimenticato) è l’affermarsi del Nominalismo, un sistema filosofico, che vanifica la stessa possibilità di parlare di “natura” (e di “legge naturale”) perché, partendo da una concezione del tutto singolare della realtà, nega la possibilità che il “concetto” si riferisca a ciò che la realtà è. Esso è considerato come un semplice flatus vocis, un’etichetta appiccicata dall’esterno alla realtà per mera convenzione, che non ha dunque nulla a che fare con la sua essenza. “Natura” e “legge naturale”, in quanto appartenenti all’area dei concetti, risultano di conseguenza del tutto svuotati del loro contenuto e perciò resi evanescenti. A questo primo dato si associa (e con esso interagisce), tanto sul versante laico che su quello religioso, una concezione radicalmente pessimistica dell’uomo. Da un lato, rifacendosi alla lezione della storia di cui ripercorre le fasi salienti, Machiavelli evidenzia come in essa si susseguono regimi autoritari che mirano a contenere con la forza l’ordine sociale, altrimenti destinato a esplodere in forme incontrollate di conflittualità; dall’altro, Lutero considera l’uomo come essere intrinsecamente corrotto (corruptio naturae), che si può salvare solo mediante la fede e la grazia quali doni divini. Questo pessimismo antropologico impedisce (e non può che impedire) – come è facile intuire – che ci si possa riferire alla “natura” quale fondamento dell’agire politico, e rendono pertanto del tutto impraticabile il ricorso alla “legge naturale”.
La situazione che ne scaturisce vanifica la possibilità di ogni forma di fondamento? E, se non è così, quale modello alternativo viene affermandosi?
Se per fondamento si intende il riferimento a un dato ontologico immutabile è evidente l’impossibilità. Ma questo non significa negazione di ogni teoria fondativa della politica. Già Machiavelli cui si è alluso sviluppa una propria teoria fondativa incentrata sulla figura del Principe, il quale gode di un potere assoluto e deve governare con il ricorso alla forza (il leone) e all’astuzia (la volpe), avendo come criterio-guida la ragion di Stato. Ma la vera alternativa è costituita dal passaggio da una concezione “naturalistica” – quella ricordata della grecità e della Scolastica – a una concezione “contrattualista”. Il più radicale rappresentante di questa svolta è Hobbes, il quale partendo da una visione pessimistica dell’uomo, guidato nello “stato di natura” dal principio di autoconservazione e dall’egoismo del desiderio, non può che concepire l’altro come nemico (homo homini lupus) e dare vita, di conseguenza, a una situazione di conflittualità permanente (bellum omnium contra omnes) con esiti radicalmente distruttivi. La fuoriuscita da questa situazione esige allora che si faccia il passaggio dallo “stato di natura” a uno “stato artificiale”, fondato sul consenso a regole ben definite, oggetto di un contratto, il quale ha, a sua volta, bisogno di un’autorità dotata di un potere assoluto, il Leviatan, che lo faccia rispettare. Questa dottrina è all’origine dell’affermarsi degli Stati assoluti in un momento storico segnato peraltro in parallelo, grazie alle grandi rivoluzioni americana e francese, all’illuminismo e in particolare al pensiero di Locke, dalla nascita della teoria dei diritti umani, che costituiscono il presupposto di una democrazia liberale. Ciò che soggiace, in ogni caso, a entrambe le concezioni è una visione negativa dell’altro, considerato un limite e persino un nemico. La stessa affermazione: “La mia libertà finisce dove ha inizio la libertà dell’altro” nasconde in realtà una visione dell’altro come ostacolo al pieno esercizio della propria libertà, anziché come socio con cui collaborare per costruire progetti comuni. La politica è allora concepita in negativo come la via da perseguire per mantenere (anche con l’intervento della forza) un ordine fondato sul rispetto dei reciproci diritti.
Come ovviare ai rischi di questa ipotesi fondativa? E con il ricorso a quale modello?
Sia il modello “naturalistico” tradizionale sia quello “contrattualista” della modernità risultano incapaci di fondare in termini costruttivi la politica come promozione di una polis ordinata e pacifica, in cui tutti e ciascuno attingano la propria realizzazione. Nel primo caso – quello del modello “naturalistico” – l’impraticabilità è legata a una fondazione anacronistica, statica e assolutistica, che non considera il dinamismo dei processi evolutivi della società. Nel secondo – quello “contrattualista” (anche nella versione liberale) – il limite consiste in una visione riduttiva e negativa della politica chiamata a garantire l’ordine pubblico piuttosto che a promuovere il bene dell’intera cittadinanza. Il modello alternativo che è allora possibile ipotizzare in quanto sembra interpretare meglio lo statuto della politica come arte della polis, è un modello duttile e positivo che affonda le sue radici in un’ontologia relazionale, nel superamento cioè di una concezione individualistica dell’uomo, che sta alla base tanto del contrattualismo quanto dell’ideologia liberale, per fare spazio a una concezione dell’uomo come essere costitutivamente relazionale; in altre parole, come soggetto di e in relazione, che si autocomprende e si autorealizza solo nel rapporto con l’altro. Di qui scaturisce una concezione della politica che, fondandosi sulla socialità come attributo essenziale dell’umano, si pone al servizio dello sviluppo di tutto l’uomo nella sua integralità personale e di tutti gli uomini nell’unità della famiglia umana mediante la creazione di un tessuto di relazioni sempre più profonde ed estese. La politica ritrova così la sua vera identità: da attività negativa (e meramente difensiva) acquisisce una funzione positiva, quella di fare sintesi delle istanze sociali, contribuendo alla costruzione di una polis sempre più universalistica e solidale.