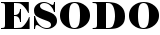di Giannino Piana
Su molte questioni che riguardano specialmente i campi della bioetica e della morale sessuale e matrimoniale, la “dottrina cattolica” chiama in causa il concetto di “natura” oggi contestato da più parti. Che cosa pensi? Ritieni sia ancora possibile fare ricorso a esso?
Il concetto di “natura” (e conseguentemente di legge e di diritto naturale) per il significato che ha storicamente assunto, soprattutto a partire dagli inizi della modernità, è oggi difficilmente utilizzabile.
La tradizione giusnaturalista ha fatto di esso un concetto statico di ordine giuridico e di carattere esclusivamente biologico, che non tiene conto della globalità degli elementi che costituiscono l’identità dell’umano e della dimensione storica propria della condizione umana, perciò del carattere evolutivo della moralità. In realtà, se si risale alle origini, si scopre che non è sempre stato così. Il ricorso alla “natura” e alla “legge naturale” è presente in un filone consistente della filosofia greca, con riferimento ad alcune strutture aperte alle quali occorre ricorrere per formulare e valutare le leggi positive emanate dall’autorità politica. La “legge naturale” è considerata da Aristotele come espressione di una “giustizia superiore” rispetto a quella “legale”; giustizia alla quale occorre, in ultima analisi, riferirsi per orientare correttamente la propria condotta. Anche la migliore tradizione medioevale si muove nella stessa direzione. Tommaso D’Aquino afferma che la specificità della “natura umana” consiste nella “razionalità” (natura ut ratio), la quale consente all’uomo di conoscere e di intervenire sui processi biologici (e non solo) della propria struttura personale. Si direbbe, usando una terminologia moderna, che l’uomo non è solo “natura” ma anche “cultura”; anzi, che è soprattutto “cultura” in quanto quest’ultima è il carattere distintivo proprio della sua “natura”. Se si intende così il concetto di “natura”, cioè in senso dinamico e finalistico, l’istanza alla quale esso rinvia è oggi più attuale che per il passato. Esso consiste in un’infrastruttura aperta dell’umano, la quale consente di porre un argine – come ci ha ricordato Habermas – a interventi che rischiano di comprometterne gravemente l’identità – si pensi in primo luogo alle manipolazioni genetiche – e di individuare un terreno comune, un dato transculturale, che permetta alle diverse culture di entrare tra loro in dialogo: se tutto si riducesse a “cultura”, si potrebbe dare vita soltanto a una società ad arcipelago, costituita cioè da isole del tutto separate tra loro. È come dire, in definitiva, che all’inattualità del termine – personalmente preferisco usare il termine “umanità” (humanitas) – esiste l’attualità dell’istanza a esso soggiacente, che va ricuperata sia pure in modo innovativo.
La gerarchia cattolica ribadisce con forza il riferimento alla “legge naturale”, mettendo in evidenza come l’abbandono di tale categoria porti con sé il rischio del soggettivismo e del relativismo. È proprio così? O si può invece costruire, a prescindere da essa, un’etica condivisa fondata sulla responsabilità?
Ho già accennato alla difficoltà a usare termini come “natura” e “legge naturale”, divenuti anacronistici per l’accezione riduttiva che hanno acquisito nella cultura odierna e la percezione negativa che di essi si ha a livello di opinione pubblica. Anche quando vengono utilizzati in modo corretto non possono che suscitare il sospetto di una visione fissista dell’eticità. Questo non significa (e non può significare) rinuncia ad alcuni fondamentali valori, che hanno il loro presupposto in un dato originario dal quale non è possibile prescindere. Quando si abbandona del tutto tale ancoramento, Il rischio del soggettivismo e del relativismo senza dubbio sussiste. Ma si tratta di non identificare il soggettivismo con la centralità del soggetto (e della coscienza) nella definizione della moralità e il relativismo con il carattere relativo di ogni norma etica. Il fatto che si dia moralità soltanto laddove e fin dove sussiste la libertà del soggetto e che esista, in ogni caso, una costitutiva storicità dell’agire umano non può essere ignorato né accantonato. Il richiamo alla categoria di “responsabilità” corrisponde perfettamente a questa concezione. Responsabilità viene dal verbo latino respondere (dare risposta), che si declina in “rispondere a qualcuno” e “rispondere di qualcosa”. Nel primo caso – “rispondere a qualcuno” – vi è in gioco il coinvolgimento del soggetto, che non è l’individuo ma la persona, che è per definizione un soggetto relazionale, il cui agire va commisurato al bene dell’altro; nel secondo caso – “rispondere di qualcosa” – il riferimento è a un dato oggettivo costituito dall’analisi delle conseguenze positive e/o negative dell’azione; analisi che rimanda a un quadro di valori gerarchicamente ordinati, che vanno mediati nelle diverse situazioni. Il modello è dunque quello di un’“etica del possibile”, la cui struttura implica il rapporto tra soggetto e oggetto, superando in tal modo tanto il rischio del soggettivismo e del relativismo quanto quello di un’oggettività assoluta e astratta, che non è in grado di interpretare l’evolversi costante della realtà.
D’altra parte non si può negare che esistano oggi fenomeni come l’individualismo, che fa della libertà un diritto all’autodeterminazione la quale non sopporta alcuna limitazione; o come la dinamica del desiderio, che è sempre più considerato come il criterio di valutazione del comportamento umano. Come reagire a queste tentazioni?
Le due tentazioni da te ricordate hanno senz’altro una presenza rilevante nella società odierna. Individualismo e dinamica del desiderio sono nell’ambito della cultura dominante al centro della valutazione della condotta umana. Lo slogan “vale ciò che vale per me; vale per me ciò che mi piace” (che è oggetto cioè del mio desiderio) rappresenta bene ciò cui ci si riferisce da parte di molti nel fare le proprie scelte. La reazione a questo stato di cose può verificarsi soltanto se si ricupera – come ho già ricordato – il concetto di “persona” come essere di e in relazione, che prende autocoscienza di sé e si realizza soltanto in un rapporto positivo con l’altro e con gli altri. La pandemia, che speriamo in fase di soluzione, ci ha reso edotti della verità di questa lettura della realtà; ci ha messi cioè di fronte alla consapevolezza che non ci si salva da soli, ma sempre soltanto insieme. La possibilità che questo si verifichi è tuttavia legata alla concreta acquisizione di valori come il riconoscimento della dignità di ogni persona umana, il rispetto della giustizia e dell’equità e l’attivazione di forme di solidarietà, a partire dai bisogni delle categorie più marginali.
A destare preoccupazione vi è poi, in questo contesto, la messa in discussione della stessa differenza tra uomo e donna, con la riduzione dell’identità di genere a semplice costrutto socioculturale, che può subire nel corso della storia della persona anche più variazioni. Come si può valutare questa tendenza, che rappresenta una vera rivoluzione antropologica? Che cosa ne pensi?
Sono d’accordo con te nel ritenere che si tratti di una vera rivoluzione antropologica, la quale suscita serie preoccupazioni. La teoria del gender, quando si trasforma in ideologia, diviene pericolosa, perché porta con sé il rischio dell’erosione delle basi stesse dell’identità umana. L’avere messo in luce il dato socioculturale come elemento costitutivo, perciò imprescindibile, della costruzione dell’identità di genere è senza dubbio un fatto importante. La riduzione di tutto al dato biologico, come in passato avveniva, rispondeva a criteri positivisti e materialisti, che è giusto aver superato. Ma questa indubbia conquista non può comportare il rifiuto di ogni riferimento alla struttura biologica, che rappresenta un elemento essenziale (anche se non esclusivo) della definizione dell’identità personale. La realtà dell’umano è più complessa, e implica attenzione all’interazione tra i due fattori evidenziati, ambedue necessari al costituirsi dell’identità di genere.